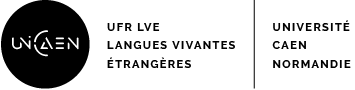La guerra del postino di Cetica
Avvertenza
Quando ho incominciato a intervistare mio zio Gilberto Giannotti, o forse dovrei meglio dire a chiacchierare con lui, non avevo certo idea di quante cose mi avrebbe raccontato e quanti fatti, più o meno importanti, mi avrebbe svelato. Erano i primi giorni di gennaio del 1998 e all’inizio lui era un po’ restio a parlare davanti a un microfono, ma poi pian piano s’è abituato e, anzi, se qualche sera tardavo, mi telefonava per sollecitarmi, ansioso com’era di raccontare. E così tutte le sere passavamo un paio d’ore insieme: lui parlava e io ascoltavo, registrando tutto. Con noi c’era sempre sua sorella Gabriella che ogni tanto interveniva approvando quello che Gilberto raccontava o aggiungendo qualcosa o anche per dire «no, questo no, sarebbe meglio non dirlo», ma veniva subito zittita: lui voleva sempre raccontarmi tutto, anche se qualche fatto era un po’ scomodo o delicato. In questo modo sono passati sette o otto mesi durante i quali ho raccolto molte memorie e ricordi di mio zio. Dopo questa prima fase ho cominciato a trascrivere tutto quello che mi aveva detto e, giorno dopo giorno, rileggendolo, Gilberto aveva sempre da commentare, correggere o aggiungere qualcosa perchè nuovi particolari e nuovi ricordi gli venivano continuamente alla mente. Siamo andati avanti in questo modo fino al 7 Agosto 1999, il giorno prima della sua morte 1Nato a Strada in Casentino il 17 febbraio del 1916, Gilberto Giannotti è dunque morto nel suo paese natale l’8 agosto 1999. , e mi ricordo che gli ultimi racconti riguardavano Don Giovanni Bozzo. Di una cosa sono certo: Gilberto non nutriva risentimenti verso nessuno e le lunghe chiacchierate che abbiamo fatto mi hanno convinto che abbia voluto ricordare e parlare di questi avvenimenti non solo per rivivere e ripercorrere con me il viaggio della sua vita, ma anche perchè desiderava che la memoria di questi fatti e il ricordo della sua famiglia, degli amici, dei conoscenti e anche dei suoi avversari di un tempo non andassero perduti ma restassero sempre con noi, nelle nostre menti e nei nostri cuori.
Il testo qui pubblicato è tratto dalla parte centrale del libro Mi ricordo che… di Gilberto Giannotti 2G. Giannotti, Mi ricordo che... Memorie, storie, lettere di Gilberto Giannotti, a cura di G. Ronconi, Castel San Niccolò (Ar), Edizioni Fruska – Gianni Ronconi, 2001 (stampata in un numero limitato di copie, tale edizione è ormai esaurita)., parte che riguarda in particolare il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Le memorie, raccontate da mio zio in vernacolo casentinese e così fedelmente trascritte nel succitato libro, sono state invece in questa nuova edizione da me italianizzate per poter essere lette senza difficoltà da tutti ed essere anche più facilmente tradotte in francese e tedesco.
Scoppia la guerra3La prima volta che andò a fare il militare, Gilberto fece dieci mesi a Perugia in fanteria, da inizio marzo a fine dicembre del 1938, ed aveva l’incarico di dattilografo. Nel maggio del 1940 fu richiamato come telefonista e piantone, con destinazione Arezzo, prima nella caserma Piave, poi al Distretto dove rimase fino al marzo del 1942, quando fu rimandato per la seconda volta in congedo. Nel luglio del ’43, fu richiamato ancora ma dopo l’8 settembre tornò a casa.
Il 10 giugno del 1940 scoppiò la guerra. Mi ricordo molto bene che era di lunedì, perché a Strada c’era il mercato. Il sabato prima avevo avuto un permesso e stavo per rientrare a Arezzo. Era già quasi mezzogiono e io ero in piazza che aspettavo di montare nel pulmino del Francioni per andare a Porrena e tornare in caserma, quando Mussolini cominciò il discorso nel quale annunciava agli italiani che l’Italia entrava in guerra. Il Francioni4Il Francioni era il titolare della ditta che svolgeva il servizio di corriera, cioè di trasporto passeggeri, da Strada in Casentino a Porrena, dove Gilberto poteva prendere il treno che lo portava ad Arezzo. allora aveva un pulmino basso, basso, che ci si saliva con uno scalino, io ero lì che stavo per mettere i piedi dentro, quando in quel mentre sentii dalla radio Mussolini che diceva: «Popolo Italiano, corri alle armi...» Laggiù, davanti al comune a sentire alla radio il discorso del Duce, c’erano naturalmente tutti i fascisti di Strada con i loro capi, quei fanatici esaltati, tutti a favore dell’entrata in guerra. E allora io, con un piede nello scalino del pulmino, gli dissi: «Oh, che aspettate, io vado, vedete, io gli do retta a Mussolini e voi state qui? Lui vi ha chiamato e voi non venite?» e monto su. O5Interiezione tipica toscana usata per introdurre un’esortazione o una domanda retorica e nelle risposte per esprimere meraviglia (forse forma apocopata di «ora»). te, lì vicino c’erano molti fascisti e fra questi un bottegaio di Strada, uno che al momento opportuno fece alla svelta a cambiare bandiera, tanto è vero che negli ultimi mesi di guerra suo figlio era fra i partigiani, e sarà bene che non dica altro, che disse: «Sentilo lui, è sempre il solito! Non c’è proprio niente da fare con quello.» Mi avrebbero picchiato, se potevano. Ma il Francioni mise in moto e partì.
Come poi venni a sapere in seguito, quel giorno ci fu Cameo di Casanini, un uomo alto, che a un certo punto, finito il discorso di Mussolini, da solo e in mezzo a tutta questa gente impazzita di gioia per l’entrata in guerra, gridò forte: «Abbasso la guerra.» Questi fascisti non la presero certo bene e l’avrebbero voluto anche bastonare, fanatici e prepotenti come erano, ma, siccome in quel momento c’era troppa gente, non lo fecero. Seppi anche che la sera in due o tre persone andarono a casa sua a minacciarlo, per fargli rimangiare quello che aveva detto, ma non ci fu nulla da fare, lui rimase della sua idea.
Mussolini disse, quando entrò in guerra: «Mi serve un morto per sedere al tavolo delle trattative, per essere al tavolo dei vincitori e per la divisione dell’Europa.» E invece il morto non fu uno solo e nemmeno tre o quattro. Nel nostro comune ci furono i primi morti di queste guerre. Infatti il primo morto della guerra in Africa, nel 1935, fu uno di Valgianni, un bersagliere. E il primo morto della guerra in Albania, nell’aprile 1939, fu Giuseppe Ghedini, il farmacista qui di Strada che era stato richiamato. Ancora la guerra non era stata dichiarata, ma quando questo partì da Bari per una missione, il suo aeroplano precipitò, forse a causa d’una manovra sbagliata. I primi a saperlo, a Strada, siamo stati io e Corrado Landi, perché la sera che arrivò il telegramma dal ministero con la notizia della sua morte, eravamo dentro l’ufficio postale, in quanto ci avevano dato l’ordine di stare al telegrafo per essere subito pronti se arrivavano notizie sulla guerra. Quando la salma tornò a Strada ci furono i funerali solenni con tutte le autorità e, se non sbaglio, mi sembra che intervenne anche Italo Balbo.
Un altro personaggio importante che venne a Strada durante il fascismo fu Starace, il segretario del Partito Nazionale Fascista. E di questo, c’è un fatto divertente da raccontare. Quando Starace arrivò a Arezzo, i fascisti lo presero e lo portarono in trionfo. Lo strano fu che, invece di essere contento, lui non voleva e si mise a urlare: «Mettetemi giù, mettetemi giù!» urlava. «No, no», dicevano, continuando a portarlo in giro. «No, no, mettetemi giù, non voglio», insisteva. «No, no. Mettetemi giù, vi ho detto. Mi avete schiacciato una palla.» A quel punto lo misero giù e lui: «Vi avevo detto di mettermi giù. Mi avete preso per un coglione!» «No, no. Non è vero», tutti a dire. «È vero, vi dico, è vero. Mi avete preso per un coglione.» Questo successe veramente, a Arezzo. Non mi ricordo se a Strada fu portato in trionfo, ma forse no.
Una lettera di Federica
Durante tutto il periodo che sono stato a Arezzo, da casa non hanno fatto altro che scrivermi: babbo, Annina, Aurora, Giannetto, anche Federica6Annina era la zia di Gilberto e viveva in casa con lui. Giannetto, Aurora e Federica erano fratello e sorelle di Gilberto. Con loro viveva anche lo zio Gigi. Gilberto aveva un’altra sorella, Leda, e naturalmente la mamma, Lisa., che allora faceva le elementari, e questo anche se quasi tutti i sabati ero a casa, o con il permesso o senza:
11 Ottobre 1940, ANNO XVIII, ti mando questo piccolo librettino insieme al mio ricordo affettuoso e sincero. Leggilo attentamente, è proprio composto per voi che combattete per la nostra Italia. Vero che lo leggerai? Bravo. Ti sono sempre vicina con il cuore e sento tanto desiderio di riabbracciarti presto. Quale gioia se tu potessi ritornare dopo aver riportato una grande vittoria. Prego sempre a questo scopo e specialmente che la Madonna vegli su di te proteggendoti. Anche tu non dimenticarti di raccomandarti a Dio, e guarda di non offenderlo con il peccato. Ricevi tanti baci dalla tua sorellina.
Questa letterina Federica la scrisse quando faceva la quinta elementare. Si vede chiaro, da questa lettera, cosa dicevano a scuola ai ragazzi, cosa gli suggerivano di scrivere. Specialmente alle elementari le maestre erano tutte a fare propaganda al fascismo, e forse per qualcuna non c’era alternativa, se volevano continuare a insegnare. Era un continuo lavaggio del cervello ai ragazzi per farli venire su nel modo giusto per loro. Ma quando il fascismo cascò, contro queste maestre ci furono delle sanzioni e infatti a qualcuna per un po’ di tempo gli fu impedito di tornare a insegnare. Queste sanzioni vennero fatte anche contro tutti quelli che si erano dati parecchio da fare, come qualche squadrista o qualche fanatico esaltato. Cosa tu vuoi, ne avevamo subite tante e poi tante che non si poteva certo lasciarle passare tutte, così, come se nulla fosse. Poi, piano piano, le cose cambiarono e tutto tornò come prima anche perché venne fatta un’amnistia. E infatti anche queste maestre di Strada tornarono a insegnare. E sai chi fece questa amnistia? Togliatti!
Che poi questa era una lettera suggerita e controllata dalla maestra, lo puoi vedere anche da come gli avevano fatto scrivere la data, [l’anno] XVIII dell’era fascista. Io così non l’ho mai scritta e sono anche sicuro che nessuno di casa nostra l’ha mai messa in questo modo. Si vede cha a scuola avevano fatto un librettino da mandare ai soldati, ma stai sicuro che sicuramente sarà stato un’esaltazione del fascismo e della guerra. E poi, pensa, se io ero a Arezzo, come facevo a combattere per la vittoria?
La visita al Sangallo e l’inizio del contrabbando
Era già diverso tempo che cercavo un modo per farmi dare il congedo quando, finalmente, verso il febbraio del ’42, mi riuscì di prenderlo. Fu quando mi visitarono per i miei denti, che da parecchio tempo erano tutti cariati a causa della piorrea e la visita la passai a Firenze, all’ospedale Sangallo. Uscito da Sangallo, quel giorno rimasi a Firenze e dal momento che era un freddo boia, andai al magazzino del Freschi per scaldarmi, e lì ci trovai il Chiarini7Il Freschi era un camionista che ogni giorno trasportava merce dal Casentino a Firenze e viceversa.. Poi, la sera, presi il treno per Arezzo. La mattina dopo mi diedero il congedo e tornai a casa.
Dal giorno del congedo, e fino a che non mi richiamarono, si cercò di cavarsela tutti il meglio possibile, come naturalmente facevano anche le altre famiglie. Ma di merce in giro, di tutti i generi, ce n’era poca e fu allora che cominciò a esserci il contrabbando. Infatti per portare quasi tutti i prodotti da una provincia a un’altra, ci voleva un permesso, che a Arezzo si doveva chiedere alla Sepral, un ufficio che si trovava alla prefettura. Questi permessi riguardavano quasi tutto e mi sembra che solo la frutta e gli ortaggi ne fossero esclusi. Inoltre c’erano le persone incaricate di controllare che le merci prive del permesso di viaggiare non fossero trasportate di contrabbando. A Strada, quelli che controllavano erano specialmente Rino e Gegio Ferretti8Tutti e due si chiamavano Ferretti ma non erano parenti., due sciagurati che, anche se erano fascisti, non erano certo cattivi. E con Gegio eravamo anche amici da tempo: sai i funghi che il mio babbo ha comprato da lui. Loro due sorvegliavano in modo particolare il camion del Freschi, perché andava e veniva sempre da Firenze e per quelli che viaggiavano continuamente era certo più facile trovare della roba da portare di nascosto. E anch’io, quando tornavo da Firenze col camion del Freschi dopo aver consegnato quello che s’era fissato con i nostri clienti, per esempio mele e funghi, cercavo di portare sempre qualcosa: ma chissà quanta roba ci sarà stata lì dentro che veniva portata di contrabbando. Infatti il contrabbando c’era per tutte le merci che non si trovavano perché erano razionate, come il cuoio, l’olio, il caffè, il vino, il petrolio e tante altre. Noi, in quel periodo, s’aveva un magazzino al Piazzone9Il Piazzone è una piazza di Strada in Casentino, mentre la Giovannina era il nome di un bar. e di solito, quando si tornava da Firenze, s’andava prima a girare dalla Giovannina e poi, lesti, lesti, si scaricava in modo da far ripartire prima possibile il Freschi per Bibbiena.
Una volta si seppe, prima di arrivare a Strada, che Rino e Gegio stavano a aspettarci al bar della Giovannina. Io qualcosa avevo, ma poca cosa. Cosa si fece? Invece di andare a girare al bar e poi scaricare, quella volta ci si fermò prima al Piazzone e si scaricò svelti, svelti. Poi il Freschi andò a girare dalla Giovannina e ripartì per Bibbiena. Rino e Gegio, appena lo videro, lo seguirono, credendo che andasse a scaricare, come faceva di solito. Prima non l’avevano visto, perché in quel periodo c’era l’oscuramento e si doveva viaggiare con i fari coperti da una tendina o da un panno. Io aspettai che il camion ripassasse in giù e poi, con calma e facendo finta di nulla, mi avviai verso casa. Loro, appena mi videro, capirono subito come erano andate le cose: «Guarda chi c’è. E il camion? Forse ce l’hanno fatta» disse uno dei due, ma non si mossero e a me non dissero nulla. Io zitto, feci finta di niente e andai a casa. Gegio e Rino controllavano tutto, anche le site10La sita era la corriera pubblica di trasporto passeggeri che faceva servizio per Firenze.. E se a volte ci trovavano, in qualche cesta o in una borsa, qualche prodotto che non era in regola, stai sicuro che nessuno diceva che quella roba era la sua, non trovavano mai il padrone.
Il 25 luglio del ’43
L’ingegnere Spreafico stava in una villa, lassù sopra al borgo. Già da diverso tempo io andavo a portargli la roba di bottega, in bicicletta o col barroccino, e duravo anche una gran fatica a spingerlo per quella salita. In questa villa c’erano tre o quattro donne a lavorarci come domestiche e questo ingegnere doveva essere stato un pezzo grosso degli armamenti ma, come mi aveva fatto capire, era contrario a Mussolini.
Quel giorno, il 25 luglio del ’43, era domenica, arrivo e mi dice: «L’ha sentita la radio stamani?» Dico: «No, sono uscito presto da casa e sono stato in bottega fino a ora. Perché, c’è qualcosa di nuovo?» Vedevo che non sapeva cosa fare e poi, quando non c’era più nessuno in giro, mi dice: «C’è una novità, stasera alle undici diranno che Mussolini è cascato.» Senti, lui la sapeva già questa cosa. Segno che aveva dei contatti buoni, sennò come avrebbe fatto a saperlo? Quando tornai a Strada, non mi ricordo bene con chi passai la mattinata, ma poi incontrai il Bagnoli e gli dissi: «C’è una novità. È cascato Mussolini e lo dicono stasera alle undici.» E lui: «E questa da dove tu l’hai tirata fuori? Se non lo sa nessuno come fai tu a saperlo?» «L’ho sentito in un posto e se te lo dico vuol dire che c’è chi me l’ha detto». Certo non si poteva fare tanto chiasso, ma il pomeriggio, dopo che gli avevo detto di Mussolini, io, Cicalino e Bruno di Marco, si prese e s’andò a festeggiare per conto nostro al Pizzico, da Lisa. Quando poi si tornò a casa non si faceva altro che cantare una canzone che purtroppo non mi ricordo più tanto bene:
Scendete dal trono vigliacchi
Deponete le vostre bandiere
Sorge il sol dell’avvenire...
poi mi sembra che dicesse così
I signori che nulla fanno
Ci han promesso una dimana 11Un domani, un futuro.
E una dimana s’aspetta ancor...
La sera, come tutte le domeniche, c’era il cinema e, quando la gente cominciò a uscire, verso le undici, tutti a bocca aperta a sentire alla radio che Mussolini era cascato. Un po’ di tempo dopo fu anche arrestato, non mi ricordo di preciso quando, e fu portato prigioniero in Abruzzo, a Campo Imperatore. Fu lì che i tedeschi con un commando, con un aereo, fecero un’azione e andarono a liberarlo, per fargli poi fare la Repubblica di Salò, per fargli fare ancora più danni di quelli che aveva già fatto. Quando cascò, a qualche fascista gli prese la paura forte, in quel momento anche loro pensarono come noi che per il fascismo fosse finita. Ma più che altro si impaurirono quelli che non erano proprio fascisti duri e che non avevano mai dato noia a nessuno. Addirittura mi ricordo che mi toccò andare a accompagnare a casa sua, in Prato, uno di loro perché gli era preso paura e aveva il terrore che qualcuno l’aspettasse all’Alberotorto. Ma ci andai volentieri perchè era una brava persona. Io e i miei, e tutti quelli come noi, s’era tutti al settimo cielo e dentro di noi si pensava che con la caduta di Mussolini il fascismo fosse finito davvero. E invece il peggio doveva ancora venire.
L’8 settembre del 1943
La seconda volta che mi richiamarono sotto le armi fu verso il luglio del ’43 e, quando tornai al Distretto, andai direttamente nello stesso ufficio dov’ero già stato per tanto tempo. Ma questa volta ci stetti poco, solo un paio di mesi, fino al 10 Settembre, due giorni dopo il fuggi fuggi generale, anche del Re. L’8 settembre del 1943 tutti a casa. Infatti in quel giorno, il giorno dell’Armistizio, il Re e Badoglio, che era stato fatto capo del Governo al posto di Mussolini, pensarono bene di mettersi al sicuro a Brindisi, dove c’erano gli alleati, fregandosene dell’Italia e degli italiani. L’esercito si ritrovò senza comandanti e così andò allo sbando, si sfasciò. Quasi tutti scapparono che l’importante ormai era mettersi al sicuro dai fascisti e dai tedeschi, alleati dell’Italia fino al giorno prima.
Quando ci fu il fuggi fuggi generale, io non venni via subito, ma scappai due giorni dopo, il 10, perché il mio colonnello, Chiaja, mi chiese di aspettare qualche giorno perché voleva vedere cosa succedeva. Ma il 10 settembre al Distretto arrivarono i tedeschi. Misero un autoblindo fermo davanti al portone, perché non uscisse nessuno e entrarono dentro. Io, con altri miei compagni, si fuggì da una porta sul retro del Distretto, ma il colonnello Chiaja no, lui fu preso e portato via. Quando tornai dalla Germania, seppi che era stato deportato anche lui, dapprima in Germania e poi in Polonia da dove tornò dopo la guerra. Un giorno il maresciallo dei Carabinieri di Strada mi mandò a chiamare perché aveva avuto una richiesta di mie notizie da parte del colonnello Chiaja. Lui pensava che anch’io fossi stato fatto prigioniero e credeva che quel giorno che presero lui, l’8 settembre, anch’io fossi stato portato via e deportato. Andai a trovarlo, a Arezzo, perché anch’io volevo incontrarlo e sapere come stava e devo proprio dire che quando ci si incontrò fu un momento proprio commovente.
Dunque, scappato dal Distretto, andai subito a una gabina dell’Enel, dove sapevo che c’era in servizio Alfredo Aloigi. Poi mi misi in contatto con Landino Landi, che era a Arezzo in casa di Severo Mugnaini, perché mi portasse dei vestiti, volevo mettermi in borghese per non rischiare di essere preso dai tedeschi. Lui non trovò di meglio che mandarmi un vestito di Severo, la giacca e i calzoni. Ma siccome io ero secco e piccino e Severo era alto e grosso, io in questo vestito c’entravo dieci volte e allora non me lo misi, venni via sempre vestito da militare. Si partì per il Casentino insieme ad altri, con Vito e lo Zavani, uno di La Spezia, con i quali s’era insieme al Distretto. Prima a piedi, lungo la ferrovia, fino a Giovi, poi lì si prese il treno per tornare in Casentino.
La Todt
Mussolini, dopo che era stato liberato dai tedeschi a Campo Imperatore, scappò in Alta Italia sotto la loro protezione e qui, dopo un po’ di tempo, fece la Repubblica di Salò. Per questo i fascisti diffusero un bando che diceva che tutti quelli nati fra il 1898 e il 1926 si dovevano presentare dalla milizia fascista12La milizia era una specie di polizia fascista che venne istituita in tutti i comuni. Chi faceva parte di questa milizia aveva compiti di sorveglianza e di controllo sulla cittadinanza, e in special modo sugli antifascisti., per essere arruolati. Ma siccome in tanti non andavano, quelli della milizia andavano loro a cercare quelli che si sarebbero dovuti presentare, per arruolarli a forza. E cosa si fece in parecchi per non presentarsi? S’andò a lavorare con la Todt, in Vetrignesi. La Todt era un’organizzazione del lavoro tedesca ed era a questa che era stata affidata la costruzione della Linea Gotica. Era questa Todt che faceva le piazzole, i camminamenti, le fortificazioni, le buche anticarro e tutto quello che sarebbe servito a combattere contro gli americani e fermarli nella loro avanzata, perché i tedeschi pensavano che gli alleati sarebbero passati da queste parti. E pagavano anche, per far sì che la gente andasse a lavorare, ma alla maggior parte non gli importava certamente di essere pagati, che l’importante era sfuggire all’arruolamento forzato per Salò. S’era in tanti lassù, quasi tutti quelli che secondo i fascisti si doveva partire per la Repubblichina. Fu lassù che si seppe cosa avevano fatto i tedeschi a Vallucciole13A Vallucciole, situato nel vicino comune di Stia, il 13 aprile del 1944 ci fu una feroce strage nazifascista durante la quale furono trucidati, senza alcuna pietà, 108 civili fra donne, vecchi e bambini, anche di pochissimi mesi., ma non solo i tedeschi, perché sicuramente con loro c’era anche quelli della milizia fascista. Dopo questi due o tre mesi con la Todt, si decise di tornare a Strada. Un po’ s’aveva paura che alla fine ci portassero via e un po’ ci s’era tutti impauriti per quello che avevano fatto a Vallucciole.
Dopo che s’era tornati a Strada, mi sembra che fosse di lunedì, capitò una donna di Bibbiena, che fu poi ammazzata dai partigiani, a dire che chi voleva essere pagato, per aver lavorato alla Todt, si doveva presentare da lei in comune. Era di sicuro una scusa per riprenderci e portarci via. Ma mi sembra che sparirono quasi tutti e a riscuotere e a lavorare alla Todt non ce ne ritornò nemmeno uno.
Don Giovanni Bozzo
I tedeschi ci stettero fissi qui e ci stettero anche un bel pezzo. In tutto questo periodo ne fecero di prepotenze, era proprio un periodo davvero tremendo, s’era sempre in pericolo. Un giorno dopo l’altro cercavano sempre di prendere qualcuno per portarlo via, o di dare noia alle donne, che erano rimaste quasi tutte sole. E meno male che fra i Salesiani14I Salesiani, congregazione religiosa fondata da San Giovanni Bosco, abitavano a Strada in un grande immobile chiamato da tutti il Collegio in quanto, insieme ai sacerdoti, vi erano moltissimi ragazzi fissi, a convitto. Ma il Collegio era frequentato anche da quasi tutta la popolazione di Strada per motivi religiosi e per attività scolastiche e ricreative. c’era un prete, Don Giovanni Bozzo, che intervenne diverse volte per aiutare la popolazione altrimenti sai quanto andavano peggio le cose, quanti ne ammazzavano. Questo prete parlava il tedesco, era l’unico in tutta la zona che lo parlasse, ed era sempre a discutere con i comandanti tedeschi, per convincerli a lasciar stare i paesani, in questo modo riuscì ad aiutare parecchio la popolazione. Certo che era facilitato dalla conoscenza del tedesco, ma molto dipese dal fatto che lui si dimostrò sempre parecchio capace, si vede che sapeva bene cosa dire e come dirlo.
Ogni volta che ce ne fu bisogno lui intervenne e riuscì a impedire diverse rappresaglie. Quando i partigiani ammazzarono un tedesco, al ponte del Rio, lui intervenne per far rilasciare moltissime persone, sia ragazzi che uomini, che erano stati presi e che probabilmente sarebbero finiti male, forse fucilati per rappresaglia. Si dette davvero tanto da fare, sempre, ogni volta che ce n’era bisogno, rischiando anche di rimetterci lui, non poteva certo sapere come potevano reagire i tedeschi alle sue continue richieste di lasciar stare la popolazione. Ma nemmeno lui potette fare nulla per evitare quello che successe a Cetica.
Renato del Codino se lo ricorda bene sicuro come l’ha salvato, me lo ha raccontato diverse volte. Avrà avuto diciotto o diciannove anni e si era ammalato, mi sembra, di pleurite. Un giorno dei tedeschi fecero irruzione in casa sua e con lui c’era solo la sua mamma, Maria. Lo volevano portare via perché lo accusavano di essere un partigiano e ogni resistenza sarebbe stata di sicuro inutile. Erano entrati in camera sua e lo avevano già fatto alzare quando videro un biglietto, scritto in tedesco, appoggiato sul comodino accanto al letto. Appena lo lessero lo lasciarono subito stare e se ne andarono di corsa. Tu lo sai cosa c’era scritto in quel biglietto? C’era scritto che Renato aveva una malattia infettiva e non doveva avere contatti con nessuno. E chi l’aveva scritto? Don Bozzo! Lui aveva pensato a questo stratagemma nel caso che i tedeschi avessero fatto irruzione in casa sua. Senti che idea aveva avuto. E non aveva detto nulla a Renato e nemmeno alla sua mamma: aveva fatto tutto di testa sua. Domandaglielo a Renato se è tutto vero! Senti che uomo che era!
Certo che si dette tanto da fare, era tutto un camminare in qua e in là per aiutare chiunque era in pericolo, tutto uno sventolare di tonaca, e sicuro che ne salvò di vite. E proprio per questo non ho capito come mai, finita la guerra, il paese si è scordato di lui, mai che nessuno l’abbia ricordato come credo era giusto che fosse. Sbaglio?
Giuseppe Farina
Quando ero a lavorare per la Todt, a Cetica e in montagna i fascisti non andavano quasi più, a causa dei partigiani, ma alla fine questi presero Farina e lo fucilarono. Giuseppe Farina era stato podestà di Strada e mi sembra che venisse dal Mugello. Prima di venire a Strada era maresciallo ma, quando successe questi fatti, mi sembra che fosse andato in pensione con il grado di tenente. I partigiani, o qualcuno d’accordo con loro, gli avevano portato via la divisa da tenente, la sciabola e sembra anche il corredo della figlia. Poi gli mandarono a dire che se voleva indietro la sua roba doveva andare a riprendersela al ponte di Pagliericcio. E questo scemo ci andò. Quando andava in su, trovò per la strada, poco prima di Rifiglio, zio Gigi che tornava da portare la posta a Valgianni.
Farina gli disse: «O Gigi, venite, venite con me, che mi fate compagnia. Ci devono essere i partigiani che mi aspettano al ponte di Pagliericcio.» E Gigi: «Ma lei cosa ci va a fare?» E Farina: «Mi hanno preso la divisa e il corredo di mia figlia e mi hanno detto che me lo rendono.» «Ma la venga indietro con me, non ci vada. Dia retta a me, non ci vada all’appuntamento, torni a casa che è meglio per lei. Non vada a cercare guai», insisteva Gigi. E quell’altro: «Bisogna che ci vada, mi hanno detto che mi rendono tutto, me lo hanno promesso.» Non ci fu nulla da fare, Gigi non riuscì a convincerlo e Farina andò al ponte. I partigiani lo presero, lo portarono via e lo fucilarono nell’abetina di Cetica, quella per la strada della Badia. Era il 28 giugno del 1944 e me ne ricordo bene perchè il giorno dopo ci fu la strage di Cetica. E quello stesso giorno questi partigiani volevano portare via anche mio babbo. Come al solito lui era andato a Cetica a portare la posta e quando i partigiani che avevano preso Farina arrivarono a Cetica, per andare verso la Badia passarono nel luogo dove in quel momento c’era babbo. Lui quando li vide venire su con Farina capì subito che lo avrebbero fucilato e allora cercò di farlo rilasciare: «Ragazzi, ma cosa fate? Cosa lo prendete a fare. Ma lasciatelo andare, che lui non ha fatto nulla di male.» «State zitto voi, cosa vi intromettete», gli dissero. E babbo insisteva: «Ma via, lui è uno sciagurato che non ha fatto male a nessuno. Lasciatelo andare via.» Babbo aveva ragione. Farina era un esaltato, ma non era cattivo! Ma i partigiani dopo un po’, visto babbo che insisteva tanto, se la ripresero anche con lui e alla fine gli dissero: «Se tu insisti tanto, vuol dire che tu sei come lui. Si fa una cosa, si prende anche te. Vieni con noi che si sistema anche te», e gli puntarono il fucile addosso.
Meno male che lì con babbo c’era Altero, che se non c’era lui chissà come andava davvero a finire. Quando vide che i partigiani volevano portare via babbo intervenne subito: «Ma cosa fate? Siete impazziti? Lasciatelo, cosa avete per la testa? Vi dà noia? È a portare la posta ed è anche un antifascista, e di quelli veri». Meno male che furono ragionevoli e dettero retta ad Altero. A Cetica lo conoscevano tutti, ci faceva il maniscalco e lo conoscevano sicuramente anche loro. Tant’è vero che si convinsero e lasciarono andare babbo.
Rappresaglie
I tedeschi, dopo ogni attacco che facevano i partigiani o anche dopo una sola fucilata, per rappresaglia cominciarono a fare i rastrellamenti e a bruciare le case. E anche se a sparare erano sempre i partigiani, i tedeschi se la riprendevano sempre con quelli che non c’entravano nulla. Come quella volta che i partigiani spararono ai tedeschi da Capezzi e poi, quando questi risposero al fuoco, presero e scapparono. Quando i tedeschi andarono lassù non ci trovarono più nessuno e certo questo fu un bene, perché se ci trovavano qualcuno gli sparavano di sicuro, ma per rappresaglia bruciarono tutto. Quando però avevano risposto al fuoco, i tedeschi avevano ferito Stella e lo sbaglio grosso fu poi quello di portarlo all’ospedale a Poppi. Lì c’erano i tedeschi che, quando scoprirono che era stato ferito da una loro arma, lo portarono in Campaldino, vicino al fiume, e lo fucilarono con diversi altri. Come ti ho già detto, per rappresaglia i tedeschi avevano fatto anche una retata di uomini, che poi fortunatamente Don Bozzo riuscì a far rilasciare.
Anche io una volta stavo per fare un attentato vicino a Strada, al ponte del Rio, dove c’era sempre fermo un autoblindo tedesco. Una sera si partì, s’andò laggiù e ci si nascose sotto il ponticino, io, Cicalino e altri di Strada, con due o tre bombe a mano. Gli si voleva tirare, si voleva vedere di fare qualcosa. Ma alla fine non se ne fece di nulla perché Lisa, la mamma di Clara, c’implorò di stare fermi, perché aveva paura che gli bruciassero la casa, lì al Pizzico. Noi gli si dette retta e non si fece nulla, ma si vede che la sua casa era destinata ad essere bruciata perché, dopo qualche giorno, i tedeschi la bruciarono per rappresaglia contro l’uccisione di un loro soldato, che avvenne proprio vicino al ponte del Rio. E anche in Prato, dove i partigiani tirarono a una motocarrozzina, i tedeschi bruciarono parecchie case.
Ma fu a Pratarutoli e a Cetica che i tedeschi fecero la rappresaglia più atroce e tremenda e successe il 29 Giugno, proprio nel giorno di San Pietro e Paolo. Il giorno avanti i partigiani avevano ammazzato Farina ma, anche se questo forse fu un motivo in più per fare quello che poi fecero, i tedeschi e i fascisti fecero questa strage per vendicarsi di alcuni attacchi che avevano avuto dai partigiani. Questi, pochi giorni prima, avevano ammazzato due tedeschi al ponte del Rio, due tedeschi che sembra avessero la Croce Rossa al braccio. Quella rappresaglia fu una cosa spaventosa e in quel giorno i tedeschi, ma per me con loro c’era anche i fascisti, ammazzarono parecchia gente. Cominciarono a Pagliericcio, dove ammazzarono un Grifoni, che non fece a tempo a entrare in casa. Poi, lungo la strada, ammazzarono i Municchi, un ragazzo di quindici anni e il suo babbo, e a Pratarutoli altri cinque. Lì cominciarono anche a dare fuoco alle case. Dopo arrivarono a Cetica, e lassù ne ammazzarono parecchi, più di una decina di sicuro. Di questi due o tre erano di Cetica, e meno male che quasi tutti gli abitanti erano già fuggiti, avvisati dal rumore dei primi spari a Pagliericcio e Pratarutoli, mentre gli altri che erano stati uccisi erano partigiani che avevano cercato di difendersi. Poi cominciarono a far saltare e a bruciare, insomma a distruggere molte case, ma le case dei fascisti, anche se a Cetica erano pochi, non le toccarono. E secondo te, come facevano a sapere quali erano quelle dei fascisti e quelle no, se con loro non c’erano anche i fascisti, questi qui della zona? Nella serata dello stesso giorno i partigiani, quando i tedeschi tornarono verso Strada, li attaccarono vicino al ponte di Pagliericcio e ne ammazzarono parecchi.
La mia mamma il giorno dopo andò a Cetica, a piedi, per avere notizie di mio fratello Giannetto, che si sapeva che era con i partigiani in Pratomagno. Lassù seppe che a Cetica lui non c’era, ma quando tornò in giù i capelli gli15Nel toscano, il pronome personale maschile «gli» (a lui) sostituisce anche quello femminile «le» (a lei) e il plurale (a loro). erano diventati tutti bianchi, tornò terrorizzata dalle scene spaventose che aveva visto. Nei giorni seguenti i tedeschi, prima di partire verso il Nord, bruciarono e minarono un monte di case a Prato, a Rifiglio, a Pagliericcio e in tanti altri posti e dappertutto continuarono ad ammazzare gente, parecchia, tutta gente innocente, come a Montemignaio. E man mano che se ne andavano, minarono e distrussero tutti i ponti. A me sembra che da queste parti rimase in piedi solo il ponte romanico di Cetica.
Bombardamento a Casa Patriarca16Gruppo di case diviso da una strada, molto vicino al fiume Solano.
Quando ci fu il bombardamento a Casa Patriarca, il 25 luglio del 1944, fra i primi a correre fu Don Bozzo e poco dopo arrivò anche Alfredo, il tuo babbo. Nel momento che arrivarono le bombe lui stava andando a Garliano dalla parte di qua del fiume, per un viottolo attraverso i boschi, e quando vide cosa era successo attraversò subito il fiume per andare a portare soccorso. Quello fu un bombardamento americano e doveva colpire la casa del Sabatini, quella accanto al Solano, perché c’era un comando tedesco di SS: si vede che qualcuno aveva fatto una segnalazione agli americani. Questi bombardieri sbagliarono e solo alcune delle bombe che sgangiarono cascarono sopra alla casa da colpire, ne trovarono anche una grossa non esplosa nel fiume, ma più che altro queste bombe presero un’altra casa, quella del Folli, che era di là dalla strada. Certo nessuno se l’aspettava, sennò potevano andare sotto, nella cantina, che quella resisteva di sicuro, ma non ci andarono o non fecero a tempo. Per via di questo bombardamento morirono due figli del Folli, Cecilia e suo fratello più piccolo, Pietro, e la donna di servizio con suo figlio. Giovanni Folli invece rimase mutilato alla mano, mentre la sua mamma, Luisa, e la zia Antonietta rimasero illese.
Deportato
Il 6 di agosto del 1944 era domenica, i tedeschi ci portarono via. I tedeschi avevano fatto un manifesto dove c’era scritto che tutti gli uomini fra i 18 e i 60 anni si dovevano presentare, come dicevano loro, per andare a lavorare ma in effetti, come poi successe, per finire in Germania. Noi, quelli che si dovevano presentare, non si sapeva cosa fare e in molti andavano a parlare col Luzzi, Giulio, che lui non lo toccavano per via dell’età, per avere un consiglio.
Quella domenica andai anch’io da lui ma mi fece cenno di non entrare perché aveva gente. Io gli accennai con la testa che volevo mettere la bicicletta su nel palco, in casa sua, e lui capì che, oltre a metterci la bicicletta, mi ci volevo nascondere anch’io: col capo mi fece cenno di sì. Fui proprio imbecille, perché la bicicletta ce la misi, lassù, ma io non ci rimasi, che se ci rimanevo quel giorno non mi trovavano. Ero sempre lì che aspettavo di parlare con Giulio, quando arrivò Saul dal Piazzone a dirmi: «Oh, Gilberto, i tedeschi dicono di presentarci, cosa si fa, ci si presenta o no?» Ci si doveva presentare alla Ferrea, dove i tedeschi avevano fatto un recinto per metterci tutti quelli che prendevano. E come due perfetti imbecilli, alla fine ci si andò, quelli ci presero e ci portarono via!
Qui a Strada i tedeschi ci presero in molti, si sarà stati in 150, e ci chiusero tutti in questo recinto insieme agli altri che avevano preso il giorno prima a Garliano, a Cetica, a Pagliericcio e in altri posti. Si erano appostati dalla mattina presto e avevano messo un blindato al Collegino, nascosto, e uno a Casaricciolino. Tutti quelli che venivano in paese, prima li facevano entrare, poi li prendevano e li portavano laggiù, al recinto. E anche quelli che erano andati alla prima messa, quella della sei e mezzo, che quando erano entrati in chiesa non s’erano accorti di nulla, poi quando erano usciti, erano stati presi e messi nel recinto.
Dopo, come scrisse Cesario nel suo diario: «Partenza da Strada con l’illusione di un lavoro provvisorio nei pressi di Stia»17Cesario Ceruti era un amico di Gilberto e venne deportato in Germania insieme a tutti gli altri. Dal momento della sua cattura e fino al giorno in cui trovò asilo presso un campo degli americani, Cesario annotò quello che succedeva in un piccolo diario. Gli eventi descritti, che occupano solo 28 pagine del suo libretto, coincidono con quelli del racconto fatto da Gilberto. Il diario è ora posseduto da Gianni Ronconi. Indicheremo d’ora in poi questo testo in nota con il termine in corsivo Diario seguito dalla pagina citata., chi con i camion e chi a piedi ci portarono tutti a Porrena, alla Cantina di Pietro Vettori. E Cicalino? Lui fu davvero stupido. Ce la fece a scappare e a tornare a casa, ma siccome perse tempo a abbracciarsi e a baciarsi con sua moglie, lo videro e si fece riprendere dai tedeschi che lo riportarono a Porrena. Dopo un paio d’ore, ci rimisero nei camion e si cominciò il viaggio per la strada di Pratovecchio e Stia. Qualcuno, quando si passò da Pratovecchio, saltò giù dai camion e si mescolò in mezzo alla gente per non farsi ritrovare, ma furono in pochi, perché la paura che sparassero era tanta.
Quando si cominciò a andare su per [il passo della] Calla, a parecchi ci venne in mente che si poteva cercare di scappare in una di quelle curve, ma quando ci si mise a parlarne fra noi, ci fu chi cominciò a gridare e a opporsi, dicendo che i tedeschi avrebbero sparato alle famiglie e ammazzato quelli che erano a casa. Nel camion dove ero io, c’era un tedesco, uno solo, a sedere in uno sgabellino vicino alla sponda. Qualcuno diceva: «Ora, a una curva, gli si dà un colpo, e si scappa tutti.» Sarebbe bastato spingerlo, sarebbe sicuramente cascato di sotto e si poteva scappare come ci pareva. Mi ricordo che fra i più accaniti per provare c’erano Nello Ferrantini e Fiocco. Avrebbero fatto fuoco e fiamme, se gli altri erano d’accordo. Ma quelli più vecchi si opponevano, avevano paura delle conseguenze: «No, no, fermi. Non si può fare nulla. Se ci proviamo vanno a Strada e ci bruciano tutte le case». Gli altri, quelli che volevano tentare di scappare, a ribattere: «Proviamo, tanto non lo sanno da dove si viene, siamo in tanti.» Infatti ci avevano preso da Poppi, da Stia, da Bibbiena, da Ortignano, da tutte le parti del Casentino. Fra quelli che si opponevano in tutti i modi, c’erano tre babbi con i figli: Emilio Paggetti con suo figlio Aldo, poi Guido Francioni con Mauro, e Buzzino con Silvano. Tutti a opporsi perché avevano paura che succedesse qualcosa di peggio. Alla fine quel tedesco, con tutto quel parlottare, s’accorse che si stava macchinando qualcosa, si mise ritto e cominciò a urlare, puntando il fucile, e il bello era che lui aveva più paura di noi. Lui con il fucile, noi senza, lui aveva più paura di noi, ma proprio per questo poi si stette fermi, perché quello alla fine poteva far partire un colpo. Così non si fece nulla e non si tentò nessuna fuga.
Dopo s’arrivò a Forlì e da lì molti riuscirono a tornare via, ma questo successe perché c’era un sergente di Bibbiena che, non si sa come fece, li prese e li mandò a lavorare per la Todt al passo dei Mandrioli. Certo, avrebbero sempre lavorato per i tedeschi, ma un conto era stare a lavorare lassù in montagna e un conto era andare in Germania. E alcuni fra questi, fra i quali Ovidio Francioni, Assuero Colozzi, Cicalino, Danilo Grifagni e qualche altro, lungo la strada scapparono e tornarono a casa. Noi che s’era rimasti, invece, si seguitò e, sempre dentro ai camion tedeschi, si cominciò il viaggio verso il Nord. S’arrivò a Bologna e, mentre si passava da dentro la città, si vide che c’era moltissima gente a giro per le strade. Noi allora ci si mise a gridare a questi, per metterli in guardia: «Scappate, scappate finché potete, nascondetevi. Se vi prendono, vi portano via», ma quelli niente, continuavano a passeggiare come se nulla fosse, forse non ci credevano. Chissà come sarà andata a tanti di loro, ma me lo posso immaginare, perché li portarono via da tutt’Italia, quelli che gli riuscì prendere.
Il 10 agosto, con i camion, s’arrivò a Verona, dove ci fecero scendere e ci mandarono in una scuola dove c’era una scala doppia. Mentre s’era lì che si saliva da una rampa, da quell’altra scendeva altra gente e fra questi c’era anche Altero, il fratello di Bubbone. Lo chiamai, senza nemmeno averlo visto. E lui, mentre scendeva, mi disse: «Ma come hai fatto a sapere che c’ero?» «Come ho fatto? Ti ho sentito cantare.» Lui cantava sempre. Altero, anche se le cose andavano male e in quel momento andavano proprio male, cantava, cantava sempre, lui aveva quel vizio di cantare. Stai sicuro che avrei riconosciuto la sua voce fra mille e, infatti, quando lo sentii, lo riconobbi subito e lo chiamai. E lui: «Gilberto, Gilberto, ci portano a lavorare, hanno detto che ci portano a lavorare.» Ma si sentiva che non ci credeva. Lui, Altero, lo portarono in Austria. A Verona ci misero in un treno che si diresse verso Venezia dove fece una sosta. Siccome ci avevano preso tutti i documenti, ci fecero anche scendere, sicuri che non si sarebbe scappati, senza documenti chissà dove s’andava e, con un carabiniere a guardia, si andò un po’ a giro per Venezia. Dopo ci portarono a Treviso, e qui ci misero nei vagoni merci. E quando ci misero in questi vagoni, tutti si capì che ormai la nostra destinazione era la Germania. S’arrivò a Villach il 12 agosto, e da lì ci portarono a Colonia.
Campo di prigionia
Da Colonia noi si risalì il Reno, sempre in treno, mentre tutti gli altri furono mandati in diverse zone della Germania. Quelli che risalirono il Reno, forse, ebbero più fortuna di quegli altri, anche se poi molti di questi andarono a lavorare con i contadini. Invece Sandro Lorenzoni, Tito Focacci, Natalone furono mandati in un campo dove stavano male e mangiavano peggio, quando mangiavano. Non gli davano nulla e erano proprio ai lavori forzati, gli facevano fare quattordici, quindici ore di lavoro al giorno. Sandro mi ha sempre detto che era in un posto tremendo e tutte le mattine ne trovavano uno morto per fame o per sfinimento o per malattia. Mi torna in mente quello che mi raccontò una volta. Lui e altri deportati erano a lavorare sopra un tetto e videro uno sotterrare un cane morto. Senti un po’, appena poterono scendere, via di corsa a disotterrarlo! Dopo lo portarono al campo, o da qualche altra parte, trovarono un pentolone, o qualcosa del genere, lo misero a bollire tre o quattro giorni e poi se lo mangiarono: senti che fame avevano! La maggior parte di quelli che erano nel campo con Sandro, e in quelli uguali al suo, morivano di dissenteria, non gli davano nulla da mangiare, qualche rotella di rapa e un po’ d’acqua calda. Lì ci morì il Gobbo di Bulletta e un Bargellini.
Il 19 agosto del 1944 ci misero, io, Cesario Ceruti, Niccolino Ceruti e Walter Donatelli, tutti in un campo, il campo 3 di Oppau, a Ludwigshafen, vicino a una zona che era piena di fabbriche. Noi siamo stati quasi sempre insieme e insieme a noi all’inizio c’era anche Guido Moretti, ma lui a lavorare andava lontano da noi, e per questo, poi, lo si incontrò poche volte. Il 23 settembre iniziò il nostro lavoro nella fabbrica Anilink Fabrik, dove, dopo più di vent’anni, ci sono tornato con Francesco e Guido. In fabbrica un po’ si lavorava, ma non è che ci si ammazzasse di fatica perché il lavoro non era pesante e poi, siccome oltre a noi deportati c’erano parecchi soldati prigionieri, i tedeschi facevano lavorare più loro che noi. Quando s’arrivò, il primo giorno, ci misero in delle baracche che non erano proprio male. C’era l’acqua calda e fredda, era dalla fabbrica che venivano i tubi dell’acqua bollente, e c’erano perfino le docce e i lavandini. Nel campo dove s’era noi non c’era il reticolato, ma una specie di recinto di legno tutto intorno, che se uno voleva veramente scappare, non c’erano problemi. I problemi erano che non si sapeva dove andare e, considerato anche che non si stava così male, nessuno scappava. E poi si veniva anche pagati, mi sembra 50 marchi al giorno.
Il 30 agosto cominciarono i bombardamenti. I bombardieri, che erano per lo più inglesi, arrivavano quasi sempre di notte e, prima di bombardare, buttavano i bengala che illuminavano talmente la zona che, dopo, ci si vedeva meglio che ora qui con questa lampada. C’era una luce che si raccattava uno spillo. Ma una delle prime volte che vennero era di giorno e, in quel momento, s’era a lavorare in fabbrica. Suonò l’allarme e tutti insieme si cominciò a correre verso i rifugi che erano stati fatti lì dentro, ma prima che s’arrivasse, a pochi metri da noi, cascò una grossa bomba. E questa bomba non esplose, perché se scoppiava non ero certo qui a raccontartela, si fu proprio fortunati. Si vede che nel nostro destino c’era scritto che le bombe non ci avrebbero fatto nulla, a me e agli altri che erano con me. Da quel momento, quando c’erano i bombardamenti, io non scappavo più come prima, la prendevo quasi comoda. Tant’è vero che un’altra volta che suonò l’allarme, io non volevo andare al riparo, volevo rimanere nella baracca dov’ero. Non volevo scappare perché, per prima cosa, quello non era un rifugio contro le bombe grosse. Lì c’erano solo dei paraschegge, fatti in cemento a arco, e la gente, anche se entrava sotto, poteva essere al riparo dalle bombe piccole, ma certo non da quelle da cinque quintali. Perciò io pensavo che era del tutto inutile che corressi là sotto. E poi le bombe a me non mi facevano nulla, non scoppiavano. Cesario e gli altri, invece, a chiamarmi, di continuo. Io non andavo, e loro continuavano a chiamarmi: «Muoviti, muoviti, senti che cominciano a bombardare...» Alla fine mi decisi, corsi dov’erano loro e mi buttai dentro. In quel momento scoppiò una bomba, talmente vicino che lo spostamento d’aria mi buttò addosso a loro. Cessò l’allarme, s’uscì e la baracca dov’ero prima non c’era più. Si vede proprio che era scritto da qualche parte che le bombe non m’avrebbero fatto nulla.
Il problema grosso che venne fuori in seguito fu quello che ogni tanto arrivavano i soldati e portavano via qualcuno, che spesso non tornava. Una sera presero anche Niccolino e Walter e li portarono via. Furono portati a lavorare fuori, all’Arbeitsfront, a fare le buche e le fosse anticarro, questo perché gli americani ormai erano vicini, e i tedeschi facevano lavorare tutti quelli che riuscivano a portare via dai campi. La paura di essere presi e portati via da un momento all’altro diventava sempre più grande, e bisognava in tutti i modi trovare una soluzione per stare più tranquilli. Per fortuna la trovai.
Nella mia fabbrica, l’Anilink Fabrik, avevo un capo chimico che si chiamava Gofman. Era una brava persona e anche un antinazista, penso, sennò non poteva certo comportarsi in quel modo. Mi ricordo ancora che questo, addirittura, quando andava a prendere da mangiare per sé, in dei vassoi portapranzo, dove gli davano anche la carne, lui, dopo averne mangiata un po’, mi faceva: «Tieni, mangiala un po’ anche te.» Ma il mangiare non era, almeno per i primi momenti, il nostro problema, anche se quello che ci davano ci bastava a malapena. Si lavorava tutta la settimana e il sabato i padroni della fabbrica ci rilasciavano un documento. Questo foglio, dove c’era scritto che s’era lavorato, lo si presentava all’ufficio addetto, e ci davano dei tagliandi che ci servivano per prendere da mangiare per tutta la settimana. Se non si presentavano questi tagliandi giorno per giorno, non ci davano nulla.
Gofman faceva tanti piaceri a me e io cercavo di fare qualche piacere a lui. Aveva una bilancia tipo farmacisti, un oggetto particolare e di precisione fatto a cannocchiale, con la quale pesava il nichel grezzo che si lavorava nella fabbrica. Il nichel veniva piano piano tritato sempre di più, prima diventava come ghiaia, poi si faceva ancora più fine, fino a arrivare a essere quasi polvere e, a quel punto, lui ne pesava una piccola parte con questa bilancia. Un giorno gli dissi che potevo fare una cassetta per metterla dentro, per trasportarla meglio, per essere sicuro che non si sciupasse quando la portava a giro. Lui mi fece un biglietto per prendere della roba in un posto vicino alla fabbrica e io gliela feci. Una bella cassettina di legno, con un manico sopra, che lui se la pigliava e se la portava dietro, tutte le volte che gli serviva. Per potercela mettere bene, la bilancia, avevo anche fatto dei canalini con i quali entrava da sé, ci scivolava proprio bene. Quando gliel’ebbi fatta e gliela portai, non smetteva di ringraziarmi: «Oh, gut, viel gut, danke schoen, viel danke schoen»18Ovvero: «Oh, gut, sehr gut,Danke schoen, vielen Dank.» contento come una Pasqua. «Tu stai a fargli tutte quelle cose, a quel tedesco», mi dicevano gli altri. Non volevano capire che si poteva stare un po’ meglio se lui ci aiutava.
E dunque, per tornare al discorso di prima, per essere più tranquilli, un giorno andai da lui e gli dissi: «Tutte le sere i soldati vengono dove si dorme e portano via qualcuno. Ma non c’è un sistema per non farci portare via? Come si può fare? Non è possibile trovare un modo per stare più al sicuro, più tranquilli?» E cosa fece per aiutarmi? Mi fece il Sonderausweis vale a dire un documento, fatto dal capo della fabbrica, dove diceva che io ero indispensabile per il suo lavoro. Era simile all’Ausweis, il libretto che ci avevano fatto quando s’era arrivati, quello con la foto e con il numero, il mio era il 929, come si vede dalla mia fotografia. Ma io, dopo averlo ringraziato, gli dissi ancora: «Io lo prendo volentieri, ma come faccio con i miei compagni? Se non lo fa anche a loro, non lo voglio nemmeno io, non lo posso prendere. Siamo sempre stati insieme e non posso lasciarli nel pericolo, mentre io sono al sicuro.» Io pensavo di mettere al riparo anche Cesario e gli altri che in quel momento non lavoravano con me. Per Cesario me lo fece, e me lo avrebbe fatto sicuramente anche per Niccolino e Walter, ma in quel momento loro non erano nel nostro campo e non lo potette fare. Senti quant’era bravo, questo Gofman! E ci servì parecchio, questo permesso, perché quando arrivavano i soldati, e mi ricordo che una sera vennero anche quelli della Polizei, gli si faceva vedere questo documento e loro: «schlafen», vale a dire «a dormire», e ci lasciavano lì, dove s’era.
Si cercava di cavarsela meglio possibile, giorno per giorno, e s’era sempre alla ricerca di tutto quello che ci poteva servire per passare meglio che si poteva quelle giornate. Io avevo anche trovato un po’ di tela con la quale mi riuscì fare una specie di zaino che mi portavo sempre dietro, chiudendolo con un cordoncino. In seguito rimediai anche tre coperte per dormire, a forza di cambi, e con un’altra coperta feci i calzoni. Quando ci avevano portato lì, avevo soltanto i calzoni di tela, quelli che avevo addosso quando i tedeschi mi presero. Presi il modello dai calzoni che indossavo, ritagliai un po’ alla meglio quella coperta e poi la cucii con dei fili di lega o di rame per tenerli insieme. Erano proprio brutti, ma li tenevo sotto alla tuta che ci avevano dato, perciò non si vedevano e il freddo lo sentivo poco. Avevo anche delle belle scarpe, da alpino, e, quando andavo a dormire nei rifugi, me le levavo, me le mettevo sotto la testa come cuscino, e mi rinfagottavo tutto, con quelle coperte. E per quale motivo mi facevo il cuscino con le scarpe? Per non farmele fregare!
Anche Walter si dava da fare. Dal momento che il mangiare cominciava a scarseggiare, lui andava sempre in giro per cercarlo e lo cercava fuori dalla zona delle fabbriche, in qualche paesino lì vicino. Una volta, e questo successe pochi giorni prima di Natale, portò un sacco di farina e si fece gli gnocchi con i wurstel. Dopo Natale, ancora una volta, Walter e Niccolino furono riportati via e Cesario annotò: «Il 26 riparte la coppia per un nuovo Arbeitsfront e ritorna scappando dopo aver terminato la scorta di pane»19 Diario, p. 7.. Erano scappati e il problema grosso ora era che loro erano senza documenti, perché, al momento che erano stati portati via, i tedeschi glieli avevano sequestrati. Da quel momento dovettero stare sempre molto attenti a non farsi scoprire, sempre a nascondersi appena arrivava qualcuno. Ma non solo non avevano i documenti, non avevano nemmeno quel Sonderausweis, quel documento che si aveva io e Cesario, e per loro c’era sempre il pericolo di essere portati via da qualche soldato. E da quel momento, di conseguenza, il problema più grosso divenne il mangiare:
Cominciano i giorni ancora più tristi, abbiamo due tessere e a mangiare siamo quattro… ma con l’intervento di una buona idea di Gilberto riusciamo a mitigare questo andamento di cose. Incomincia il commercio di biscotti tedeschi, comprati a Mannheim per un prezzo irrisorio e rivenduti nei Punker con un guadagno abbastanza lauto 20 Diario, p. 8. Punker, trascrizione approssimativa di Bunker..
E una sera, da uno di questi viaggi a Mannheim, tornò solo Niccolino dicendoci che Walter era voluto rimanere per vedere se faceva dei buoni acquisti, così almeno fu quello che lui disse a Niccolino. Ma da quel giorno non si ebbero più notizie di Walter, e io lo rividi solo dopo la fine della guerra. E i soldi, i soldi facevano sempre comodo. Una volta comprai da un tedesco che lavorava con noi un chilo di pane per mille marchi, che a quei tempi erano mille lire, mettiamo. Io stetti tutto il giorno senza mangiare, il pane non lo affettai per portarlo tutto intero a Cesario e Niccolino, bello e intatto e mangiarlo con loro. Dopo qualche giorno presi un altro pane da un chilo sempre dal solito tedesco. Ma questa volta, passati due o tre giorni, questo tornò e mi disse: «Bisogna che tu mi renda quel pane che t’ho dato.» Io gli risposi: «Rendertelo? E chi ce l’ha. Ormai si è già mangiato tutto, io e i miei compagni.» Fino a quel momento credevo che lui trovasse da comprarlo, visto che ce lo vendeva tanto volentieri e, invece, per andare a comprarlo e vendercelo, lui adoperava i suoi bollini. Alla fine non aveva più bollini e nemmeno il pane. Anche loro avevano tutto a tessera, e peggio di noi!
In quei tristi giorni Cesario scrisse queste bellissime e toccanti parole sul suo diario:
I giorni trascorrono ancora più tristi, problemi da risolvere restano insoluti. Il mangiare, il dormire tutto ciò che ad un uomo occorre di ristoro, di riposo non esiste per noi. La sera si avvicina e con la sera la notte e con la notte il problema dormire, dove dormire? Polizei, acqua, bombardamenti sono le tre cose che si contrappongono al pur facile problema. Cerchiamo, domandiamo, il sonno è superiore alla paura, decidiamo carta a terra, una misera coperta sopra è l’essenziale per poter dormire. Chiudiamo gli occhi, mille pensieri affollano la nostra mente, predominante fra questi il pensiero di mamma, vediamo la nostra infanzia, tutti i minuti della nostra vita ci passano davanti agli occhi come una pellicola cinematografica, in silenzio ci diamo ai giorni felici, ricordiamo i giorni fanciulleschi, visti con una punta di amarezza. E via, via nel pensiero si delinea il presente, cari genitori che siete a casa, mamme […]. Basta, basta, non cerchiamo di pensare a tutto ciò, sentiamo un movimento nuovo allo stomaco, allontaniamo questi pensieri, per pensare cosa mangiare domani. Ecco bisognerebbe andare a rubare un po’ di patate. Polizei vogliono con il fucile spararti, non è meglio forse morire in un solo colpo che morire così lentamente[?] Abbiamo fame, se avessimo delle patate, ma condite con olio, un po’ di sale, come quando le facevate voi mamme[!] Ancora la mamma ritorna nei nostri pensieri, bisogna in ogni modo d’allontanarli, si soffre troppo. Ogni sera in questo delirio ci addormentiamo e il sonno ristoratore si trasforma in un altro sogno di paure[:] fascisti armati ci corrono dietro, non possiamo correre, sparano tanti spari, ci svegliamo di soprassalto, perdio sparano davvero[!] Bisogna fuggire, una corsa pazza nella notte illuminata da spari, da scoppi, il fiato grosso, le gambe fiacche, eppure se riusciamo ad arrivare potremo un lontano giorno rivedere i nostri genitori. Non ti fermare, corri, è a 200 metri il Punker, coraggio[!] Non ne posso più, forza ci riusciamo. Due o tre ore trascorrono, un’ora prima del giorno a dormire, e dopo, stanchi, sfiniti, nuovamente a lavorare 21 Ibid., p. 13-21..
La fuga dal campo
I bombardamenti continuavano quasi tutti i giorni e un pomeriggio presero la fabbrica dove ero a lavorare con la conseguenza che, oltre a buttare giù una parte del fabbricato, fecero scoppiare anche degli incendi qua e là. Noi si trovava riparo in alcuni rifugi che c’erano un po’ dappertutto. Dopo che il bombardamento era finito, ero molto preoccupato perché avevo paura che il nuovo zaino che non avevo fatto a tempo a portarmi dietro, con dentro le mie tre coperte, fosse andato distrutto o fosse rimasto sotto le macerie. Uscito dal rifugio, presi a corsa verso la fabbrica, ma anche Gofman corse subito dal rifugio dove s’era messo e arrivò prima di me nel locale dove eravamo prima di scappare. Quando arrivai mi vide disperato ma, sorridendo, tutto soddisfatto, mi fece: «Stai tranquillo. Non ti disperare che te l’ho tirato fuori io il tuo zaino, ho fatto a tempo a prenderlo prima che bruciasse». Capisci? Gofman lo sapeva quanto era importante per me e la prima cosa che aveva fatto, appena arrivato, era stata quella d’andare là dentro a pigliarlo e portarlo subito fuori. In fin dei conti per lui quello zaino non era nulla, ma era corso apposta per salvarmelo dalle fiamme. Era davvero una brava persona, mi voleva davvero bene e io mi sono sempre ricordato di lui con tanta riconoscenza e tanto affetto.
I bombardamenti per distruggere queste fabbriche aumentavano di giorno in giorno, e s’arrivò a essere bombardati anche quattro volte al giorno. Questi bombardieri arrivavano la mattina alle dieci, tornavano a mezzogiorno, poi il pomeriggio verso le quattro e la sera verso le otto, le nove. Mi ricordo ancora che le bombe degli inglesi non si sentivano mai fischiare e ci prendevano sempre, invece quelle degli americani fischiavano da farci impazzire, ma spesso cascavano lontano da noi. Ormai la nostra resistenza era al limite. E allora si cominciò a dire: «Qui non si resiste più con questi bombardamenti, bisogna cercare di scappare, in tutti i modi!» Poi, oltre al problema del mangiare, non si trovava quasi più dove andare a dormire. Siccome queste fabbriche erano state quasi tutte bombardate e ormai erano tutte distrutte e pericolanti, cosa succedeva? Succedeva che in quelle poche zone che erano un po’ più sicure s’era in tanti là dentro, in troppi, e i litigi e gli scontri fra tutta quella gente erano ormai all’ordine del giorno. Niccolino poi era sempre senza documenti e poteva essere preso da un momento all’altro e portato via. E così un giorno, tutti d’accordo, si prese l’unica decisione possibile: «Bisogna per forza tentare di scappare, il pericolo qui diventa sempre più grosso. Se non si va via alla fine qui ci si rimane».
In fabbrica con noi c’era un marocchino che mi ricordo aveva sposato una francese. Lui s’era fatto una specie di baracchina poco distante dalla fabbrica, dentro ci aveva messo un pagliericcio per dormire e s’era anche costruito da sé una specie di stufetta. Quando alla fine si prese la decisione definitiva di scappare, s’andò da lui e si fece uno scambio: noi gli si dette i buoni per il mangiare, quei pochi che s’aveva, e lui ci fece dormire, per una notte, nella sua baracchina. Questo perché si voleva essere fuori dalla fabbrica per poter scappare senza problemi quando era ancora buio, perché scappare di notte da dentro la fabbrica poteva essere pericoloso, non si voleva che qualcuno ci vedesse. Quando si fu pronti, la sera avanti s’andò dentro a questa baracchina per passarci qualche ora, per dormire e per aspettare il momento giusto per la nostra fuga. Era un freddo tremendo, ma con quella stufetta ci si scaldò un po’ e non si stette poi tanto male. Inoltre io avevo sempre le mie tre coperte e, tutti rinfagottati, ci riuscì di dormire un po’.
La mattina presto, era ancora buio pesto, si prende e si parte. Dopo poco, sarà stato cento, duecento metri, forse più, non me lo ricordo bene, si trova un fiume, che non si sapeva nemmeno che c’era e siccome si vedeva che l’acqua scorreva in giù, si ragionò così: «Se l’acqua va in giù, la Svizzera dev’essere dalla parte opposta. Noi si risale di là e speriamo che sia vicina.» Si camminò tutta la notte, io, Cesario e Niccolino, tutta la notte, tutta la notte, poi si schiarì e noi ancora cammina, cammina, cammina, e si camminava sempre costeggiando il fiume, stando in mezzo agli alberi per non farci vedere da nessuno, per non fare brutti incontri e... la mattina ci si ritrovò dove s’era partiti! Chi ci crederebbe che si girò tutta la notte come tre perfetti imbecilli intorno a un lago, credendolo un fiume? Ci s’accorse dello sbaglio solo quando si rivide davanti a noi la baracchina dove s’era passato la notte. E cosa si fece? Si rientrò in fabbrica e, siccome ancora nessuno s’era accorto che s’era andati via, si riprese a lavorare, facendo finta di nulla, ma con la certezza che si sarebbe ripartiti subito. Ormai non si tornava più indietro e non ci si poteva far prendere dallo sconforto.
La famiglia Fertig
Come scrisse Cesario nel suo diario: «È domenica 20 gennaio ’45. Nevica che è un piacere. Ore 7 partenza»22 Diario, p. 7-8.. La mattina, io e lui s’uscì tranquillamente dalla fabbrica, dall’ingresso, mentre Niccolino uscì togliendo qualche asse del recinto. Si sapeva già dove andare, a Heidelberg, una cittadina sopra a Mannheim, dove si sapeva che cercavano della gente per diversi tipi di lavori. La prima cosa che si fece, fu quella di buttare via tutti i documenti che s’aveva. Questo perché, se ci trovavano con il documento di quella fabbrica, ci avrebbero riportato sicuramente lì, mentre noi si voleva andare da un’altra parte, verso il Nord della Germania. Io mi tenni solo la fotografia, quella con il numero 929, ma la nascosi bene. Scrisse Cesario: «Ore 10 arrivo a Mannheim. Un amaro caffè comperato in un locale è la colazione»23 Diario, p. 8.. Dopo s’aspettò l’arrivo del treno per Heidelberg. Ma a complicarci le cose, verso metà mattina, ci fu un bombardamento che interruppe anche la linea ferroviaria e che ci costrinse a passare la notte lì a Mannheim, in una casa di civili.
Il giorno dopo, sempre sotto la neve, si riparte a piedi verso Heidelberg e si doveva attraversare il ponte sul Reno. Per nostra fortuna, per la strada non si trovò mai nessuno che ci chiedesse nulla, mai nessuno, nemmeno quando si passò il ponte sul Reno. Sopra questo ponte c’erano moltissime sentinelle e noi, per non farci fermare, quando ci s’avvicinava a qualcuno, si salutava alla tedesca: «Heil Hitler.» Oh, sembra strano, mai nessuno che ci chiedesse i documenti e, senza intoppi, s’arrivò a Heidelberg. Appena arrivati, per prima cosa s’andò a un ristorante a fare una discreta mangiata, poi ci si recò all’Arbeitsamt, l’ufficio di collocamento. Mentre s’era lì, Cesario sentì uno dell’ufficio che scambiava qualche parola in francese con un altro e siccome lui lo parlava bene, si mise a discutere con questo qui. Questo ci domandò cosa si sapeva fare e noi gli si disse che s’era contadini. Lo si disse perché s’era saputo che stavano cercando delle persone da mandare presso alcune famiglie di contadini per aiutarle nel loro lavoro, perché gli uomini erano tutti al fronte. E infatti ci dissero che ci avrebbero destinati a Laudenberg, vicino a Mosbach, dove avevano urgente bisogno proprio di contadini. Il buffo fu che all’inizio, quando ci dissero che c’era una richiesta di «Schaefer», che in tedesco voleva dire contadini24La parola «Schaefer» di fatto significa «pastori»., noi si capì «Scioffer», alla francese, che vuol dire autisti, e si stava per rifiutare. Ma poi si capì a tempo che in effetti cercavano contadini e s’accettò. A quel punto si prese un treno e s’andò a Mosbach. Poi, con un altro trenino, s’andò verso Laudenberg e lì si sbagliò! Successe che, invece di scendere alla stazione di questo paese, non si scese perché non ci s’era accorti d’essere arrivati, e quando ce ne accorgemmo il treno era già ripartito, anche se ancora non aveva ripreso velocità. Allora cosa si fece? Ci si buttò dal treno! Meno male che andava ancora piano e, dal momento che era venuta tanta di quella neve che c’arrivava alla vita, non ci si fece niente.
Per un po’ si camminò in mezzo alla neve, poi a un certo punto si vide una luce e ci s’avvicinò. Era una casa di contadini. Noi gli si fece vedere i fogli che ci avevano dato all’Arbeitsamt e quelli ci fecero entrare. E anche in quell’occasione si incontrò delle persone per bene. Noi gli si disse che si poteva anche dormire nella stalla, ma il padrone di casa, un vecchio, ci volle per forza far dormire in casa, ma prima di tutto ci fece fare una grossa mangiata. La mattina ci chiamò presto perché il treno stava per tornare e si doveva andare alla stazione, per riprenderlo e tornare a Laudenberg. Però, prima di partire, ci fece fare un bella colazione! Si prese il treno e finalmente s’arrivò alla stazione di Laudenberg, dove si vide molta gente in attesa. Noi ci chiedevamo cosa ci facevano lì, e per scherzo, fra noi, si faceva: «Sicuro che sono qui a aspettare noi!» O non era davvero così? Ci aspettavano con ansia perché gli era stato comunicato il nostro arrivo e avevano urgente bisogno di noi per i lavori nei campi, dal momento che gli uomini e i giovani erano tutti a fare il soldato. Uno, un anziano, che forse era il responsabile, prende i nostri documenti e ci assegna, Cesario lì, Niccolino là, e io, io niente. «Ma? O questa?» dissi fra me. «E io?» chiesi al capo. «Vieni con me» mi disse quello. E mi portò a casa sua dove, anche lui, mi fece fare un’altra colazione. Dopo un po’ arriva una donna, una vecchia, mi ricordo ancora che aveva una pezzola25Termine vernacolare che designa un grande fazzoletto, un foulard. in testa, che mi prende e mi porta con sé lì vicino, a casa sua. Ero arrivato dalla famiglia alla quale ero stato assegnato, i Fertig.
La famiglia Fertig era composta da Otto, il vecchio, il capofamiglia, che aveva certi baffi lunghi così, Elise, sua moglie, la figlia, Maria, e poi c’era una sorella di Otto che anche lei si chiamava Maria. I figli, ne avevano quattro, erano tutti soldati. Prima di tutto volevano darmi da mangiare, ancora una volta, ma io gli dissi che avevo già mangiato anche troppo, avevo già fatto due colazioni e gli chiesi solo un po’ d’acqua calda per lavarmi. E fu lì che s’accorsero subito che non ero un contadino. Mi misi a torso nudo per lavarmi e videro che ero tutto pallido, sotto. Tant’è vero che il vecchio disse subito: «Du nicht Schaefer», che significa che non ero contadino. C’era delle cartoline o delle lettere, non ricordo bene cosa, lì da una parte e, indicandole, gli dissi che facevo il postino e, in seguito, gli dissi che facevo anche il commerciante. Poi gli chiesi: «Arbeit?», cioè «al lavoro?», e loro mi risposero: «Morgen fünf Uhr», vale a dire «domani alle cinque». Dovevo cominciare a lavorare la mattina dopo alle cinque, ma alle quattro io ero già pronto.
Il 23 gennaio del ’45 cominciò il nostro lavoro come contadini. A Niccolino gli toccò una famiglia con tre donne sole perché il marito di una di loro era stato richiamato. Anche lui stava bene, come stavo io, e lì, in quella casa, con queste tre donne, comandava lui, tutte e tre lavoravano per lui. Lui, solo mangiare e bere. Il bello fu che quando il marito tornò, una sera sul tardi, Niccolino era in casa e questo tedesco, quando lo vide, alzò subito le mani in alto e gli voleva dare anche il fucile, insomma quello si voleva arrendere a lui. Tu ci pensi, un tedesco che si voleva arrendere a Niccolino! E bella lui pensava soltanto a mangiare, non gli importava nulla di tutto il resto e gli rispose che non sapeva che cosa farsene di quel fucile. Questo tedesco, che era stato messo a guardia di prigionieri in un campo, era scappato e, da quel momento, visse sempre nascosto, almeno fino a quando ci siamo stati noi e penso proprio che lo rimase fino all’arrivo degli americani.
Cesario era in un’altra famiglia e lui invece non ci voleva stare, era sempre a lamentarsi: «Io vado via, io vado via, non ci sto, non fanno altro che brontolare.» Diceva sempre: «Non ci voglio più stare. Mi dicono che insudicio troppo, che vado in casa con le scarpe sudicie dalla stalla ed è un continuo brontolare.» Faceva il nostro stesso lavoro, stava nella stalla anche lui, come ci si stava noi, io e Niccolino. E si sa, nella stalla le scarpe s’insudiciano. Ma quando lo chiamavano a mangiare andava su con le scarpe tutte sudicie, piene di letame. Cosa gli ci voleva a darsi una ripulita? Ma non lo faceva mai e allora questi a brontolare, avevano ragione! Io avevo gli zoccoli, me li ero comprati, non se li poteva comprare anche lui? Quasi tutti quelli che erano lì a fare i contadini, che ce n’era parecchi, da tutte le parti, dormivano nelle stalle, come anche Niccolino e Cesario. Invece, io dormivo in camera, coi lenzuoli, e quando lo dicevo in giro, anche agli altri, russi, polacchi, quelli che ci si trovava la domenica a girellare, nessuno ci credeva. Senti che famiglia era quella. Quando dicevo che ero dai Fertig, tutti gli abitanti del paese facevano: «Ah, i Fertig, che famiglia, la migliore.» Lì da loro stavo proprio come un papa, ma come un papa di quelli vecchi, quelli che una volta si facevano portare nella poltrona.
La mattina m’alzavo alle cinque e per prima cosa andavo nella stalla, a governare le bestie e a levare il letame. Ma guai a dargli un filo di paglia asciutta, che costava meno il pane della paglia, ce n’era poca, anzi per niente. Infatti con le vacche e con un carro a quattro ruote, un carro con le sponde, s’andava a cercare la foglia delle piante invernali, si rastrellava e si caricava su questo carro per impagliare la stalla al posto della paglia vera. Io facevo quello che potevo e mai che mi abbiano fatto fare lavori pesanti o lavori che non potevo fare. Mungere, mungevano le donne. All’inizio mi chiesero di mungere, e anche se sapevo che non ero capace ci provai, ma non mi riuscì e non me lo chiesero più. Avevano tredici mucche e tutte avevano un nome con il quale dovevo chiamarle, e Otto non voleva che le trattassi male dicendogli le parolacce. E non voleva che certi comandi glieli dessi in italiano: «Perché dopo, quando tu andrai via, chi le comanda più», mi diceva, «se tu le abitui a sentire l’italiano, non mi danno più retta». Una volta successe che fui salvato da una mucca. S’era a lavorare nei campi e da uno di questi dovevo rientrare nello stradone, a piedi, e tenendo una mucca. C’era un dislivello molto alto fra questi campi e la strada e ad un certo punto, mentre camminavo per trovare il punto per scendere, tenendo una mucca alla cavezza, persi l’equilibrio e cominciai a scivolare lungo il bordo del campo, verso la strada. Questa fece come la mucca pazza, quella che si vede alla televisione, prese e allargò tutte e quattro le gambe, si piantò lì per non farmi cadere nella strada. Dopo, la governavo sempre per prima, Fanny, così si chiamava quella mucca.
Poi avevano anche i maiali. La sorella di Otto, Maria, i maiali non li faceva pulire a me, perché era una cosa non pulita e li puliva lei una volta alla settimana. Li tenevano dentro alla stalla e stavano sempre lì, senza mai uscire, perché li facevano diventare grassi, molto grassi. Pensa te quanto sudicio ci poteva essere lì dentro, ma per paura che mi insudiciassi, non mi hanno mai fatto toccare un maiale, nemmeno una volta. Io cercavo di fare nel migliore dei modi tutti i lavori che loro mi chiedevano, ma non solo: in più gli feci anche qualche lavoretto che mi veniva in mente, specialmente con il legname. Avevano, lì da una parte, un bel noce invecchiato, e un giorno ne presi un pezzetto per farci il manico alla falce fienaia. Ma quello che gli feci bene, veramente bene, e che gli fece anche molto piacere, furono diverse cassette per i fiori, quelle da mettere alle finestre.
La mattina ci s’alzava alle cinque e se alle otto non avevo finito di governare tutte le bestie Otto mi diceva, puntuale come un orologio: «Fertig, essen», «Sono le otto, colazione». A volte potevo rispondere: «Ma devo ancora finire», e lui diceva: «Sie werden warten!», «Aspetteranno!». Qualsiasi cosa si facesse, ci si fermava. Alle otto si doveva fare colazione e mai che ti facevano lavorare quando si trattava d’andare a tavola, sia che fossero le otto, sia che fosse mezzogiorno, o le quattro del pomeriggio per fare merenda o la sera a cena. E il mangiare, sempre abbondante, abbondante e buono. A colazione c’era sempre caffelatte, pane, marmellata e burro. A mezzogiorno c’era il salciccio e da bere il mosto, il vino di mele, come lo chiamavano loro. Era un po’ leggerino, bellino chiaro, ma quando bevevo un bicchiere di quel vino sentivo un gran calore nelle orecchie, e non capivo come mai, chissà che gradi può avere il vino di mele. Da noi si fa l’aceto con le mele, ma il vino mai. Avevano anche le botticine di questo mosto, uguali a quelle che abbiamo noi nelle nostre cantine. Ma ogni tanto andavo a bere un po’ di birra, quando ci si trovava a giro con Cesario e Niccolino, in un locale che c’era nel paese e fu lì la prima volta che bevvi la birra nera.
A cena si mangiavano spesso fette di pane, ma venivano servite in modo strano. Prima venivano messe a mollo a lungo nell’acqua calda e poi ci mettevano il latte sopra. E patate lesse! Loro le immergevano nel latte e io, invece, pigliavo il sale, le salavo e le mangiavo. Le patate si mangiavano anche a mezzogiorno e, in un modo o in un altro, c’erano tutti i giorni. Prendevano un secchio grande e ce ne mettevano tante da farne una cupola, in modo che quelle di sopra venivano cotte col vapore: erano quelle, quelle che si mangiava. Ognuno ne prendeva quante gliene pareva, gli si levava la buccia e la si ributtava sopra a quell’altre patate, perché quelle che non si mangiavano venivano date ai maiali. Io non ho mai patito la fame, mai. In quella casa avevano il burro, la margarina, il pane e tante altre cose da mangiare, tante! Quello che consumavo, bene, quello che non consumavo cercavo di lasciarlo sempre al giorno dopo e, piano piano, mi feci come un deposito. Il burro glielo passavano, ma quello fatto in casa era troppo meglio e si faceva di notte. Avevano un barilotto con un manico di fuori, e dentro c’erano due ventole che girando continuamente il latte facevano la palla di burro, genuino, buono. Ma prima di farlo, Otto Fertig usciva sempre di casa e guardava bene nei dintorni, sempre, per vedere che non ci fosse qualcuno, perché era proibito farlo.
E s’arrivò al giorno della nostra nuova partenza, verso la liberazione definitiva, nell’aprile del ’45:
La Domenica delle Palme, andiamo a Messa come le altre volte quando ritornando incontriamo profughi russi, italiani, francesi, che ci parlano della liberazione di Mannheim come già avvenuta. Sono le tre del Venerdì Santo, il paese è inbandierato di bianco per il prossimo arrivo dei liberatori, la nostra contentezza mischiata a un poco di paura, per la Polizei tedesca, è immensa. Da diverse persone sappiamo che già da tre giorni gli americani circolano in una strada distante da noi tre chilometri 26 Diario, p. 10-11..
Di una cosa mi sono sempre ricordato, di quel giorno di Pasqua, oltre al fatto che si vide per la prima volta gli americani. In casa mia, avevano fatto le uova sode, colorate, e mi ricordo anche come facevano a farle. Quando arrivava il momento di mettere le uova nella pentola con l’acqua a bollore per assodarle, ce le mettevano insieme a una carta velina colorata, di modo che diventavano del colore della carta velina. Mi ricordo che ne fecero una dozzina a testa, ognuno aveva le sue, e a me le dettero verdi.
Dopo il pranzo di Pasqua, il pomeriggio, io, Cesario e Niccolino andammo in un paesino vicino, dove ci avevano detto che passavano gli americani. Se non s’andava a vedere non si poteva sapere se questo era vero oppure no e infatti passarono. E fu così che la Pasqua del ’45, esattamente il 23 aprile del 1945, diventò uno dei giorni più belli della mia vita. Dopo aver camminato per tre chilometri, più o meno, s’arrivò a un bivio e fu lì che si vide un carro armato, il primo carro armato americano, fermo da una parte, con un soldato che stava a sederci sopra. A dire la verità il comportamento di questo soldato fu piuttosto strano. Gli si chiese subito una sigaretta per uno. Quando rispose, e ce la dette, una per uno, si capì che era italiano, anzi italo-americano, siciliano o calabrese. Dopo avergli detto che noi s’era italiani, si cominciò a fargli domande su domande, che so, da dove venivano, come andava la guerra e altre cose. Mentre s’era lì che si parlava, un altro soldato, che era uscito da dentro il carro armato, gli disse qualcosa a questo qui, due parole, in inglese, e quello non ci disse più nulla, nemmeno una parola. Non parlava più italiano, solo americano. Chissà cosa gli disse, vallo a sapere, forse avrà avuto paura che si fosse spie.
Dopo avvenne un fatto spiacevole. Noi, appena tornati, ci s’era messi sdraiati davanti alla mia casa, la casa dei Fertig, dove c’era una bella erbetta, ci si stava proprio bene. Otto, quando mi vide, sdraiato e pensieroso, mi disse: «Come va?» «Kranken Zahn», gli dissi che mi facevano male i denti, anche lui lo sapeva che li avevo tutti marci. «E tu stai a sedere nell’erba?» fece lui. «Ist egal», «è uguale», disse Niccolino, questo cretino, e continuò: «morgenfrhiu»27Ovvero: «morgenfrüh weggehen»., «tanto domani si parte». Oh, Otto. Come se qualcuno gli avesse sparato. E quell’idiota continuava a dire: «Eh, si sono trovati gli americani. Si va da loro, c’hanno tutto, sigarette, cioccolate...» Madonna! Otto rimase male. Oh, come rimase male. Non se l’aspettava e anche le donne, che erano uscite, avevano sentito anche loro, fecero come lui, ci rimasero parecchio male. Allora il vecchio Fertig, tutto serio, mi guardò, con uno sguardo pieno di rimprovero, mi guardò e mi disse: «Ah, gli americani. Loro sì, sigarette e cioccolate. Io niente sigarette... niente cioccolate...», come per dire: «Perché io non ti ho trattato sempre bene? T’ho tenuto in casa, t’ho dato una camera, da mangiare quanto volevi.»
Io avrei voluto restare ancora e se dipendeva da me ci sarei stato sicuro fino a che le cose non si fossero sistemate per bene. A me dispiaceva di venire via per loro, per Otto e la sua famiglia, mi avevano sempre trattato come uno di famiglia e anche per loro era un dispiacere vedermi partire, ma cosa potevo fare? Gli altri, ma in modo speciale Cesario, volevano partire prima possibile, s’era sempre stati insieme e s’era deciso che si rimaneva sempre insieme, a qualsiasi costo. E poi, alla fine, anche io ero curioso di vedere cosa facevano gli americani e come andavano davvero le cose. Ma, forse ancora dubbioso su quello che volevo fare, dicevo a Cesario: «Non pensare che, se si parte ora, gli americani prendono un camion apposta per noi e ci portano a casa.» Ma lui ormai: «Domattina si va via, si va via, qui non ci si sta più.» Chi lo sa, forse anche Niccolino sarebbe rimasto ancora un po’ di tempo, ma Cesario ormai era deciso a partire. La mattina dopo, il giorno di Pasquetta, vide che noi due s’era indecisi e allora ci disse: «Se voi non venite non m’importa, io vado via da solo. Fate come vi pare.» A quel punto si dovette partire. Mi trattarono bene fino all’ultimo, i miei, e anche se gli dispiaceva che partissi, mi caricarono di roba per il viaggio. Ero pieno, da sfamare anche i miei compagni, salsicci, il pane, da bere, e perfino le uova colorate che avevano fatto per Pasqua, mentre loro, Cesario e Niccolino, non avevano nulla. E si partì. Ma, poi, si stette più di un mese con gli americani.
Dopo la guerra, la mia famiglia, i Fertig, mi scrisse molte volte, io gli avevo dato l’indirizzo di Firenze, del magazzino del Freschi, in via Giosuè Carducci, perché gli avevo detto che ero di Firenze. Quando poi gli scrissi una lettera da Strada, la prima cosa che mi chiesero, quando mi risposero, fu se avevo lasciato Firenze. Un Natale, appena dopo guerra, gli feci un pacco natalizio. Feci un pacco, mettendoci una mia lettera, solo una lettera non tre. Invece, di tutte le cose che mandai, misi di tutto tre, vale a dire tre arance, tre limoni, tre panforti, tre torroni e sicuramente altre cose, ma di tutto tre, perché tre erano le famiglie che ci avevano ospitato. Ricevuto questo pacco, che era indirizzato a casa mia, ai Fertig, loro capirono subito, senza che io gli avessi spiegato nulla. Presero per sé un’arancia, un torrone, un panforte e così via, e gli altri pezzi li dettero alle altre due famiglie, uno a testa. Capito? Loro divisero subito con le altre due famiglie: erano proprio precisi, onesti, come ce n’era pochi in giro! Voglio vedere in quanti lo avrebbero fatto, sono sicuro che qualcuno avrebbe fatto finta di nulla. Poi tutti ci risposero, una lettera per uno, una a me, una a Niccolino e una a Cesario.
Quando ci tornai, vent’anni dopo, con Guido e Francesco, purtroppo i tre vecchi erano morti, ma c’era un fratello di Maria, la figlia di Otto. Ma lui non mi conosceva, perché allora era militare. Avevo la fotografia di lei, una foto di quando aveva diciott’anni, io gli avevo lasciato la mia vestito da militare. Lui mi dette l’indirizzo, nel frattempo s’era sposata in un paese distante da lì, noi ci si andò subito e la si trovò. Era a levare le patate e quando mi vide, dall’emozione nel rivedermi, fece un viso rosso, rosso, come quando arrivai a casa sua la prima volta. Era già nonna. Li invitai, lei, il marito e i figli, a venire in Italia, ma non sono mai venuti. Gli rammentai, per invogliarli, anche Firenze e Rimini, dove già cominciava a essere pieno di tedeschi per le vacanze. E il marito ci disse che c’era stato a Rimini, durante la guerra, come militare, e lo disse con un cenno. «Rimini?» fece lui, e indicò con le dita il petto e la schiena, come per dire che a Rimini gli sparavano sia davanti che dietro. Infatti durante la guerra c’erano gli alleati che gli sparavano davanti e i partigiani che gli sparavano di dietro, gli sparavano da tutte e due le parti. Poi telefonarono a un altro fratello, e prima che si ripartisse da lì arrivò anche lui. Ma prima di ripartire, vollero che si mangiasse, lì da loro, erano sempre i soliti, tali e quali al loro babbo. Poi, prima di ripartire per l’Italia, s’andò a trovare anche le altre famiglie. Oh, anche con loro che feste, ci corsero incontro e volevano sapere di Niccolino e Cesario. Loro, però, non ci sono mai tornati.
Dagli americani
In cammino ancora. Quanti km per Mannheim, forse 70 km. Intanto 50 l’abbiamo già fatti, tiriamo avanti. Belle strade. E Niccolino: sono stanco, altroché! Gilberto ci ferma: [Ohé], c’è un Wagen là! Cosa? Dove è? Niccolino trionfante torna con ciò che ci sarà utilissimo. I tre sacchi sopra, uno davanti, due di dietro e via! Siamo in salita, si va molto meglio che con il sacco in spalla. Incomincia la discesa, il Wagen va bene, voglio provare a salirci sopra, e... tu credi voglia andare a piedi!!! e così il Wagen parte veloce nelle belle strade asfaltate cintate da immensi boschi di abeti, risa e canti per la grande discesa si mischiano al rumore dei carri armati americani che passano, ed ogni persona ride della nostra trovata salutandoci. Di nuovo pianure, salite, discese, passono sotto le veloci ruote del nostro Wagen ed anche i km diminuiscono sempre più per arrivare alla nostra prospettata mèta. Passiamo paesi, grosse città che mostrano i segni dei recenti bombardamenti ed ancora più recente il passaggio del fronte. Russi, polacchi, francesi, tutti i rappresentanti di tutte le nazioni europee ci sorpassano, li sorpassiamo, laceri, stanchi, sfiniti, eppure nel volto non hanno più quel senso di mestizia riscontrato nell’internamento o in prigione. Tutti ci salutiamo, tutti ci aiutiamo, e la stella bianca passa veloce, dandoci ancor più la certezza che finalmente è la libertà. Il Neckar si mostra ai nostri occhi con le collinette e i castelli in una bellissima mattina di sole primaverile. Seguiamo per un buon tratto il Neckar, poi il Reno. Giungiamo al di là di Heidelberg, i ponti sono tutti quanti saltati, passiamo il Reno in barca (il Wagen non ci abbandona). Heidelberg, campo degli italiani liberati. Mangiare e bere vino in abbondanza. La sera stessa partiamo per un altro campo 28 Diario, p. 22-27..
Questo è quello che scrisse Cesario durante il nostro viaggio per trovare gli americani. Si trovarono a Mannheim, ma si fecero settanta chilometri a piedi, prima d’arrivare. E Cesario: «Finalmente, perdio, siamo liberi»29 Ibid., p. 12.. S’era in un campo insieme a tanti altri, italiani e no, che come noi erano arrivati lì con la speranza di tornare presto a casa e di stare un po’ meglio. Ci dettero subito da rivestirci, delle belle divise nuove. Mi ricordo che con la divisa c’era anche una fascia, che si doveva portare al braccio, con la scritta CIV che voleva dire Corpo Italiano Volontari, ma noi si diceva Carne Italiana Venduta. Di solito si stava senza fare nulla, si passeggiava tutto il giorno o quasi.
Tutti i giorni arrivavano vagoni pieni d’ogni roba, vagoni merci con la roba che veniva mandata ai soldati. Lì dentro c’era proprio di tutto, e per scaricarli gli americani cercavano sempre dei volontari, gli davano anche qualcosa. A volte cercavano di farci lavorare anche con l’inganno, come quella volta che c’era da scaricare, da un vagone rimasto fermo diverso tempo, dei trucioli di tornio. Ce n’era un vagone pieno, di questa robaccia, e per scaricarla davano anche i forconi e le pale, ma dal momento che questo vagone era scoperto, si era formata, oltre alla polvere, anche molta ruggine. Oltre a sporcarci, questa polvere ci dava noia anche a respirare e agli occhi. Dopo, quando la mattina arrivavano i camion a prendere i volontari, spesso tornavano via a vuoto, perché a scaricare quella robaccia non ci andava più nessuno.
Invece, quando c’era da scaricare i vagoni che erano pieni di vettovagliamento, anche questa era merce che mandavano dall’America per i loro soldati, c’era la corsa. C’era di tutto, casse d’uova, sigarette, cioccolate, scatolette, dentifrici, spazzolini da denti e tantissime altre cose. Mi ricordo che c’erano anche dei vagoni con le patate e mi sembrava strano che non adoperassero quelle dei tedeschi, che era l’unica cosa che ancora avevano. Chi lo sa? Forse non si fidavano. Ma allora sì che si andava a scaricare, e di corsa. In più si cercava anche di pigliare qualcosa per noi. Gli americani se ne accorgevano, ma stavano zitti, facevano finta di nulla. Mi vien da ridere a ripensare ad un fatto che accadde con un capitano italo-americano. Ci fu uno, un italiano, che come tanti altri s’era legato i pantaloni giù alle caviglie per farci come un sacco e metterci la roba che riusciva a prendere, che prese un schiaffo da questo capitano, e sai perché? Perché non aveva saputo rubare la roba giusta. Quest’italiano si era imbottito, mi pare, di dentifrici o spazzolini, e chissà, forse lui credeva di aver preso tutte cioccolate. Quel capitano quando lo vide che camminava così a gambe larghe, pieno di questa roba che aveva rubato, gli intimò: «Tirati giù i pantaloni e fai vedere cosa hai preso». Sicuramente lo aveva visto e, quando si tirò giù i pantaloni, gli dette uno schiaffo che io dico si sarebbe sentito da qui in Prato. «Imbecille», gli disse, «Guarda là. Di quanti ce ne sono dei tuoi compagni, nessuno ha preso questa roba. Se volevi rubare qualcosa, almeno avevi a prendere le sigarette o roba da mangiare, mica i dentifrici, imbecille. Posa tutto lì, va via e impara per la prossima volta.»
Anch’io ci andai un giorno, per vedere se mi riusciva trovare qualcosa di buono da portare via, ma non mi riuscì mai portare via qualcosa, non ero capace. Allora Cesario mi disse: «Senti come si fa. Noi si torna a scaricare domattina e tu stai qui ad aspettare.» E allora, loro portavano la roba che rubavano e io stavo lì, rimanevo a sorvegliarla. Come noi faceva la popolazione tedesca, che ormai non aveva più nulla. Cercavano sempre d’avvicinarsi e qualcuno riusciva a portare via qualcosa. La roba arrivava di continuo e non la scaricavano mica nei capannoni, ma ai bordi dell’autostrada, quella che stavano facendo da Parigi a Berlino, fatta tutta a blocchi di cemento. Dunque anche i tedeschi si davano da fare per prenderla un po’ qua, un po’ là, e, come al solito, gli americani facevano finta di non vedere, almeno all’inizio. Ma una sera qualche tedesco dette fuoco a un vagone e da quel momento non si provarono più ad avvicinarsi, perché gli americani stavano a guardia coi fucili. E non gli fecero toccare più nulla.
Durante il periodo che noi si rimase con gli americani, si verificò un fatto che mi è sempre rimasto impresso, per come era finito. C’era un russo che, durante la sua prigionia in un campo tedesco, era stato trattato male, ma male, con parecchia cattiveria da una guardia tedesca. Poi seppi che questa guardia tedesca non solo aveva trattato male lui, ma era stato d’una cattiveria tremenda, un mascalzone, un aguzzino che aveva fatto angherie di ogni genere un po’ con tutti. Questo russo andava continuamente in giro a chiedere a tutti notizie per ritrovarlo. Non voleva partire fino a quando non lo ritrovava, perché lo voleva ammazzare, si vede che le aveva fatte davvero grosse. Alla fine ce la fece a scoprire l’indirizzo e, dal momento che la casa di quest’aguzzino non era lontana, andò là per vedere se lo ritrovava. Ci trovò il fratello. Quando gli disse che cercava suo fratello e perché, questo gli disse: «Hai fatto tardi, ci ho già pensato io». L’aveva ammazzato lui, il fratello, immagina come doveva essere stato. Sicuramente questo fratello la pensava diversamente da lui, altrimenti non lo avrebbe certamente fatto. Solo allora il russo, dopo essersi assicurato che il suo aguzzino era davvero morto, partì verso casa. Doveva essere stato un criminale davvero.
Invece c’era un tedesco, un vecchio, che era stato a lavorare con noi in fabbrica alla Anilink Fabrik. Questo, quando s’era a lavorare lì, si portava dietro sempre qualcosa da mangiare e noi si stava a guardarlo mentre faceva colazione, con due fette di pane e due cetriolini sottaceto. Ci vedeva che si mangiava con gli occhi quella roba, e allora ci dava sempre qualcosa, a me e agli altri, poco, ma qualcosa ci dava. Poi, un giorno, non si vide più. O non lo rividi lì, quando s’era con gli americani, che andava in giro a cercare qualcosa da mangiare!? S’era io e Niccolino e lì per lì non lo riconoscevamo. Ci riconobbe lui, ci venne incontro. E Niccolino, subito, con una delle sue uscite: «Non abbiamo più bisogno del panino. Con gli americani ci s’ha tutto, cioccolate, sigarette, tutto quello che si vuole.» Senti, la mattina eccotelo lì, quel poveraccio. Viene da noi e ci dice: «Toh, voi avete tanta roba, come posso fare? Mi potete aiutare?», come per dire: «ora ho fame io, quando tu avevi bisogno io ti ho aiutato e ti ho dato da mangiare, ora tocca a te aiutare me.» Avevo rimediato un po’ di cioccolata e gliela detti e dopo gli procurai anche un po’ di sigarette. Questo vecchio continuò a venire ancora per due o tre volte e una mattina gli detti anche un pane. Quell’altro, Niccolino, subito: «To’, lo dai a lui? Ma dopo manca a noi.» «Però l’hai mangiato volentieri, quando te lo dava lui, imbecille», gli dissi. Aveva anche famiglia, questo qui.
Durante il periodo che si stette con gli americani, ci spostavano da un posto a un altro, e per ultimo s’arrivò a Frankenthal e lì: «lavoriamo in un magazzino di viveri, mangiare e bere, anche troppo. Frankenthal è divisa e trattamento americano, viviamo una vita da nababbi, mangiare, bere, dormire e... non fare niente»30 Diario, p. 27-28..
25 aprile 194531Il 25 aprile si celebra in Italia la Festa della Liberazione dalla dittatura fascista.
Noi s’era ancora in Germania quando in Italia ci fu la Liberazione e non si potette festeggiare. Ma da allora non è passato un anno che non si sia festeggiato come si doveva. Pochi giorni fa era il 25 aprile e, quando incontrai uno qui di Strada, il figlio di un fascista dei miei tempi, gli dissi: «Oh, che giornata che è oggi, la più bella, la più bella festa che esista. La fine della guerra, la fine della dittatura.» Questo mi guardò male e cominciò a brontolare. Non voleva che glielo avessi detto, ma io, invece, glielo dissi apposta, per fargli rabbia.
Quando finì la guerra, mi ricordo che i partigiani, che erano più informati di quelli che stavano nei paesi, tagliarono i capelli a zero a qualche fascista per punizione, ma solo a quelli che si erano distinti più di altri. Loro sapevano bene chi erano e tagliarono i capelli anche a certi che noi non si sospettava nemmeno fossero stati fascisti e di qualcuno ci si meravigliò tutti. Quando tornai a casa, ne vidi un paio a Strada, un uomo e una donna che non avrei mai creduto fossero del fascio, ma se avevano avuto la «rasata» vuol dire che lo erano stati. Certo che però fecero la rasata solo ai pesci piccoli, vale a dire a quelli che non potettero andare via, e dove andavano se non avevano dove andare, se non avevano nulla? I caporioni, che di solito erano quelli che avevano più possibilità, se n’erano andati, e alla svelta, quando le cose avevano cominciato a mettersi male per loro. Scapparono tutti verso il Nord d’Italia, per andare nella Repubblica di Salò, e anche quelli di Strada scapparono via, a famiglie intere, e i più fanatici, i più esaltati, scapparono per primi. Quando poi tornarono, finita la guerra e crollato il fascismo, erano tutti «scalzi e nudi», ed erano anche diventati tanto remissivi. Forse era anche il caso di rifarsi con qualcuno, ma tuo nonno Beppe diceva sempre: «La miglior vendetta è il perdono» e noi di casa non si dette mai noia a nessuno perché lui non voleva!
8 maggio 1945: scrivo a casa
Mentre s’era a Frankenthal scrissi una lettera, che arrivò a casa una ventina di giorni dopo che ero tornato:
Carissimi,
dopo molti mesi di ansie e paura eccomi finalmente libero, immagino la vostra contentezza al ricevere questa mia, nove mesi sono passati sotto tempeste di qualunque genere che si verifica[no] in questa terra di gente barbara, pazienza tutto finito ormai, sono libero dal giogo tedesco. Immaginate la mia gioia[,] ossia nostra perché sono insieme a Cesario e Niccolino, nel vedere il giorno di Pasqua i primi carri armati americani, è una giornata che non scorderemo mai. Come vi ho detto sono con Cesario e Niccolino, era con noi anche Walter e [Guido Moretti], dopo 5 mesi Walter partì e nulla abbiamo più saputo di lui. Guido invece possiamo quasi assicurare che sia libero come noi e spero darà notizie alla sua famiglia. Siamo ora vestiti da soldati americani e trattati come loro su tutti i rapporti. Mentre io esulto di gioia per la mia liberazione, sono altrettanto pensieroso per voi, come state, quanti giorni tristi avete passato? Questa domanda che ora posso farvi sicuro di una risposta[,] quante volte, per meglio dire ogni momento mi è giunta alla mente senza mai una risposta[; ]potrò farvi più dettagliatamente un racconto quasi un romanzo un giorno che spero sia vicino, essenziale è che tutto è finito. Termino queste poche righe perché non vedo l’ora di spedirla, salutandovi, augurandovi a tutti una buona salute come vi posso assicurare la mia ottima baci a Babbo Mamma e tutti Vostro Gilberto
8928 Italian Service Unit, A.P.O. 667 U.S. Army
Il ritorno a casa
Il 12 giugno del ’45 si ritornò in Italia. Quel giorno s’arriva a Firenze, in treno, e appena arrivati dissi: «Io non mi fermo. Se venite con me, ora vado in via Giosuè Carducci che qualcuno per tornare a casa si trova di sicuro.» E Niccolino: «No, no, io vado da un’altra parte. Quando si passa davanti all’ospedale di Sangallo, io mi presento lì, voglio la pensione.» Io non ci volli andare e lui s’arrabbiò con me, ma, capisci, era il 12 giugno e già cominciavano a esserci le ciliegie. Per questo volevo andare al magazzino del Freschi32Gilberto e la sua famiglia si servivano spesso del Freschi per portare e vendere a Firenze molti prodotti locali, smerciati nella loro bottega e che variavano a seconda delle stagioni, in special modo mele, ciliegie, castagne e funghi., in via Carducci, ero sicuro che, se trovavo qualcuno e avevo un po’ di fortuna, potevo tornare subito a casa. Non c’era nessuno, ma il camion del Freschi sì, fermo lì da una parte. Io e Cesario ci si salì dentro, ci si distese sopra, ci si coprì con le mie coperte, sempre le stesse del campo in Germania e ci si passò la notte. Ci si stette veramente bene. La mattina dopo, era ancora presto, arrivò il Chiarini: «Ma guarda che sorpresa, fece Beppe appena mi vide, cosa ci fai qui!?» «Siamo tornati ieri dalla Germania», gli risposi, e gli raccontai grosso modo come erano andate le cose. «E dire che ieri c’era il tuo babbo, qui a Firenze», mi disse poi.
Dopo s’andò in Piazza Ghiberti e ci trovai Gigi di Pelo col camion di Tito, uno di Salutio. Erano lì perché avevano portato le ciliegie e siccome, prima che i tedeschi mi avessero portato via, io e Gigi di Pelo s’era lavorato funghi e ciliegie insieme, gli dissi: «E il mio babbo, ne sai niente?» «Tu non c’eri e allora mi diceva che non sapeva cosa fare», mi rispose, dicendomi così che il babbo non aveva fatto più nulla con lui. Invece, dopo seppi che non c’era andato per niente a sentirlo. Allora gli dissi: «Ho capito, sei stato proprio bravo. Finché c’ero io, tu eri contento perché facevo il somaro anche per te, ma senza me hai subito lasciato perdere il mio babbo», e feci l’arrabbiato. Ma dopo si ricominciò lo stesso a lavorare insieme. Poi il babbo me lo disse: «Ho anche provato a cercare di comprarle, le ciliegie, ma da solo era un problema.» Ma non era che non poteva comprarle, non sapeva come fare per portarle a Firenze, bisognava andasse lui e con la posta come faceva?
Dopo mangiato si prese e si salì nel camion di Tito per tornare a casa, io, Niccolino e Cesario. Arrivati a Strada, si scese tutti al bar della Giovannina. Ma appena entrato dentro il bar, mi buttai a corpo morto sopra a una seggiola, come un fico, ero proprio sfinito, così, tutto ad un tratto. E dire che fino a quel momento non avevo avuto paura di nulla, anche quando c’era stato i bombardamenti non avevo avuto mai paura, nemmeno dei tedeschi e dei loro fucili, non mi avevano fiaccato né le sofferenze, né le privazioni, ma quando mi ritrovai lì, dentro quel bar, finalmente al sicuro a casa, si vede mi prese l’emozione e persi tutto ad un tratto le forze. Noi tre si fu fra i primi a tornare a casa e tutti a chiedere notizie di quegli altri che erano stati portati in Germania, ma chi sapeva nulla! Non solo, ma quando si tornò, la gente di Strada pensava che si fosse tornati con l’oro, non capiva che il nostro oro era la pelle che s’era riportata. Ma indovina un po’ cosa voleva fare Cesario, dopo pochi giorni che s’era tornati a casa? Voleva andare volontario a combattere contro il Giappone, proprio lui che aveva insistito tanto perché si tornasse a casa prima possibile. E noi a dirgli: «Non sarai mica pazzo, è già troppa questa di guerra.» Chi lo sa, forse gli prese il terrore di non avere nulla da fare. Prima della guerra lavorava come usciere alla Cassa di Risparmio, qui a Strada, e purtroppo, quando tornò non lo vollero riprendere, in nessun modo.
Ora, mentre io tornavo a casa, il babbo tornava da portare la posta. Si trovava poco più giù di Barbiano quando incontrò delle persone che mi avevano visto tornare e loro: «Giuseppe, cammina, va a casa, va a casa che hai una sorpresa.» «Che sorpresa?» fece lui. «È tornato tuo figlio.» Sai cosa fece? Aveva già passato le case di Barbiano e stava per venire via, ma siccome sapeva che lassù c’erano quelli che volevano vendere le ciliegie, tornò indietro, prima fissò l’acquisto delle ciliegie e poi tornò a casa. La notte stessa io ripartii per Firenze col camion del Freschi carico di ciliegie e dormii lì dentro un’altra volta. La mattina, in Piazza Ghiberti, a Firenze, ritrovai ancora Gigi di Pelo, e io subito: «Vedi che anche senza di te il mio babbo le ha comprate lo stesso, le ciliegie!»
- 1. Nato a Strada in Casentino il 17 febbraio del 1916, Gilberto Giannotti è dunque morto nel suo paese natale l’8 agosto 1999.
- 2. G. Giannotti, Mi ricordo che... Memorie, storie, lettere di Gilberto Giannotti, a cura di G. Ronconi, Castel San Niccolò (Ar), Edizioni Fruska – Gianni Ronconi, 2001 (stampata in un numero limitato di copie, tale edizione è ormai esaurita).
- 3. La prima volta che andò a fare il militare, Gilberto fece dieci mesi a Perugia in fanteria, da inizio marzo a fine dicembre del 1938, ed aveva l’incarico di dattilografo. Nel maggio del 1940 fu richiamato come telefonista e piantone, con destinazione Arezzo, prima nella caserma Piave, poi al Distretto dove rimase fino al marzo del 1942, quando fu rimandato per la seconda volta in congedo. Nel luglio del ’43, fu richiamato ancora ma dopo l’8 settembre tornò a casa.
- 4. Il Francioni era il titolare della ditta che svolgeva il servizio di corriera, cioè di trasporto passeggeri, da Strada in Casentino a Porrena, dove Gilberto poteva prendere il treno che lo portava ad Arezzo.
- 5. Interiezione tipica toscana usata per introdurre un’esortazione o una domanda retorica e nelle risposte per esprimere meraviglia (forse forma apocopata di «ora»).
- 6. Annina era la zia di Gilberto e viveva in casa con lui. Giannetto, Aurora e Federica erano fratello e sorelle di Gilberto. Con loro viveva anche lo zio Gigi. Gilberto aveva un’altra sorella, Leda, e naturalmente la mamma, Lisa.
- 7. Il Freschi era un camionista che ogni giorno trasportava merce dal Casentino a Firenze e viceversa.
- 8. Tutti e due si chiamavano Ferretti ma non erano parenti.
- 9. Il Piazzone è una piazza di Strada in Casentino, mentre la Giovannina era il nome di un bar.
- 10. La sita era la corriera pubblica di trasporto passeggeri che faceva servizio per Firenze.
- 11. Un domani, un futuro.
- 12. La milizia era una specie di polizia fascista che venne istituita in tutti i comuni. Chi faceva parte di questa milizia aveva compiti di sorveglianza e di controllo sulla cittadinanza, e in special modo sugli antifascisti.
- 13. A Vallucciole, situato nel vicino comune di Stia, il 13 aprile del 1944 ci fu una feroce strage nazifascista durante la quale furono trucidati, senza alcuna pietà, 108 civili fra donne, vecchi e bambini, anche di pochissimi mesi.
- 14. I Salesiani, congregazione religiosa fondata da San Giovanni Bosco, abitavano a Strada in un grande immobile chiamato da tutti il Collegio in quanto, insieme ai sacerdoti, vi erano moltissimi ragazzi fissi, a convitto. Ma il Collegio era frequentato anche da quasi tutta la popolazione di Strada per motivi religiosi e per attività scolastiche e ricreative.
- 15. Nel toscano, il pronome personale maschile «gli» (a lui) sostituisce anche quello femminile «le» (a lei) e il plurale (a loro).
- 16. Gruppo di case diviso da una strada, molto vicino al fiume Solano.
- 17. Cesario Ceruti era un amico di Gilberto e venne deportato in Germania insieme a tutti gli altri. Dal momento della sua cattura e fino al giorno in cui trovò asilo presso un campo degli americani, Cesario annotò quello che succedeva in un piccolo diario. Gli eventi descritti, che occupano solo 28 pagine del suo libretto, coincidono con quelli del racconto fatto da Gilberto. Il diario è ora posseduto da Gianni Ronconi. Indicheremo d’ora in poi questo testo in nota con il termine in corsivo Diario seguito dalla pagina citata.
- 18. Ovvero: «Oh, gut, sehr gut,Danke schoen, vielen Dank.»
- 19. Diario, p. 7.
- 20. Diario, p. 8. Punker, trascrizione approssimativa di Bunker.
- 21. Ibid., p. 13-21.
- 22. Diario, p. 7-8.
- 23. Diario, p. 8.
- 24. La parola «Schaefer» di fatto significa «pastori».
- 25. Termine vernacolare che designa un grande fazzoletto, un foulard.
- 26. Diario, p. 10-11.
- 27. Ovvero: «morgenfrüh weggehen».
- 28. Diario, p. 22-27.
- 29. Ibid., p. 12.
- 30. Diario, p. 27-28.
- 31. Il 25 aprile si celebra in Italia la Festa della Liberazione dalla dittatura fascista.
- 32. Gilberto e la sua famiglia si servivano spesso del Freschi per portare e vendere a Firenze molti prodotti locali, smerciati nella loro bottega e che variavano a seconda delle stagioni, in special modo mele, ciliegie, castagne e funghi.
- Casentino (Toscana)
- Cetica (Strada in Casentino)
- Pratovecchio (Arezzo)
- Firenze (Toscana)
- Venezia (Veneto)
- Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)
- Germania
- Laudenberg (Baden-Württemberg)
- Frankenthal (Renania-Palatinato)
- Campo di Oppau (Ludwigshafen)
- Deportazione
- Liberazione (Italia)
- Linea Gotica
- Repubblica di Salò
- Organizzazione Todt
- Dichiarazione di guerra (Italia)
- Fascismo
- Stragi nazi-fasciste
- Benito Mussolini
- Soldati tedeschi
- Numéro: OU001
- Lieu: Archivio privato Gianni Ronconi